
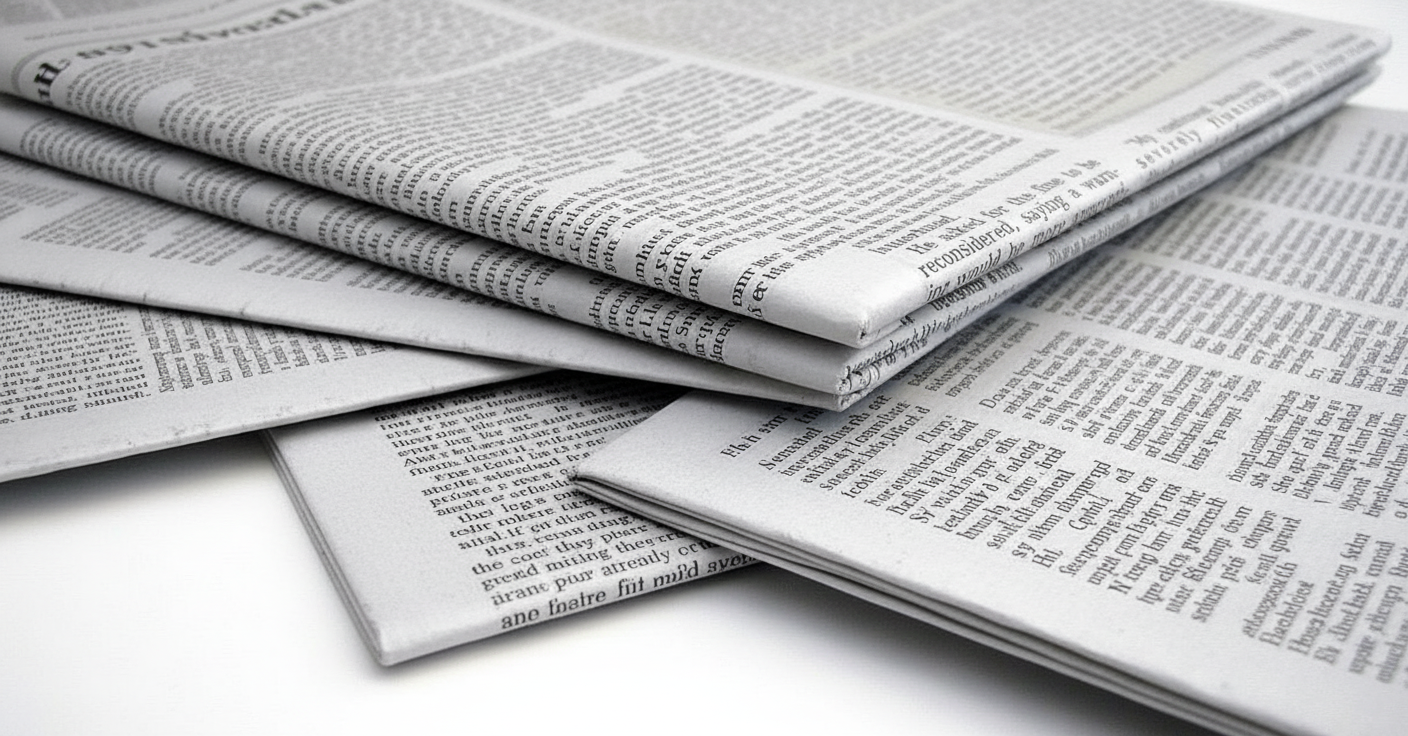
Giovanni Cagnoli
L’elezione del Presidente della Repubblica ha reso palese ciò che è evidente da tempo:
la disintermediazione dei social ha reso le comunità dei militanti obsolete e asservite a leadership spesso surreali. Il personale politico, poi, è inadeguato ad affrontare le grandi questioni contemporanee, se non in modo demagogico. Serve coinvolgere i capaci e i competenti del mondo reale. Ecco come.
La triste vicenda dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, conclusasi benissimo ma con un processo delirante, lascia sul campo una riflessione molto concreta, e cioè il completo e definitivo sfaldamento del sistema dei partiti così come lo conosciamo.
Il centrodestra non esiste più, i Cinquestelle non sono mai esistiti e spariscono dal campo, il centro è virtuale, il Partito democratico celebra una vittoria che non è sua, nella migliore tradizione dei trasformisti, il campo largo con i progressisti è un campo minato che esiste solo nella vulgata di Enrico Letta e serve solo a Goffredo Bettini e Massimo D’Alema per provare a rilanciarsi.
Dalle macerie nascerà certamente qualcosa di nuovo e diverso, ma vale la pena chiedersi se il nuovo debba essere nella forma del partito come lo conosciamo dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Troppe cose sono cambiate e questi nostri partiti riflettono l’incapacità del sistema politico di prenderne atto, ben lontano dalla rapidità degli elettori che invece esiste, ancorché abbia prodotto danni gravi con il voto ai Cinquestelle nel 2018. Un voto che è insieme causa ed effetto del problema.
Le principali cause della dissoluzione del sistema dei partiti sono a mio avviso tre:
- L’avvento dei social media e in generale la rapidità di circolazione dell’informazione riducono la capacità di intermediazione dei partiti. Il grande pubblico oggi sa tutto in diretta senza giornali che “traducono” (spesso travisando per fini propriamente politici), senza l’effetto massivo delle tv generaliste che hanno permesso il fenomeno Berlusconi, senza soprattutto la capacità dei leader di trasferire mezze verità a chi li vota, pena l’essere immediatamente smontati dai social.
Questo effetto è non solo irreversibile, ma anche crescente nel tempo. Difficilissimo pensare a fenomeni di illusione di massa analoghi a quelli di inizio Novecento nel mondo di oggi e, se vogliamo, la crisi dei populisti di cui si iniziano a vedere segnali non solo in Italia ne è testimone. Matteo Salvini e Beppe Grillo possono ancora durare un po’ vendendo bufale, ma in pochi anni il loro ciclo si esaurisce. Così come si esaurisce la “superiorità morale” della sinistra destinata inesorabilmente a perdere le prossime elezioni a valle dell’insipienza delle proposte soprattutto economiche alla luce dei vincoli di sistema. - La personalizzazione del partito nel suo leader è stata il tratto dominante degli ultimi anni come effetto della democratizzazione e della iper-semplificazione dell’informazione. Non proponendo più una visione di società ma solo l’immagine del capo, il partito è identificato con il leader. Silvio Berlusconi per primo, ma poi Matteo Renzi, Beppe Grillo (non Giuseppe Conte che è un figurante di basso livello), Matteo Salvini, Giorgia Meloni assurgono al ruolo di “leader maximo”, rappresentando soprattutto sé stessi. E qui viene il problema insuperabile.
Assurgono a persone/partito personaggi modestissimi che non hanno né cultura istituzionale, né cultura in senso lato. Non hanno nulla di nulla. Sono stati solo capaci di dominare la macchina del partito e poi raccogliere consensi in campagna elettorale con il contratto per gli italiani di buona memoria, con il reddito di cittadinanza o con l’immigrazione.
Fa eccezione Renzi che in questa legislatura con quaranta parlamentari e il due per cento nei sondaggi ha deciso due governi e il Presidente della Repubblica, dimostrando capacità politiche fuori dal comune. Slogan e personalizzazione sono l’unica cifra da parte di figure che, guardate individualmente, sono senza alcuno spessore.
Quando poi costoro governano (l’obiettivo stesso dei partiti) emergono drammaticamente i limiti enormi di persone tanto modeste da non trovare candidati credibili per fare il sindaco di Milano o di Roma, da non trovare ministri decenti che accettano di lavorare con loro, da non trovare soprattutto soluzioni a problemi molto complessi che devono affrontare. Il processo di selezione è inverso rispetto ai problemi da affrontare. Emergono solo incapaci demiurghi di una breve stagione, cui segue il fallimento inevitabile.
Il Pd, in questo contesto, è forse ancora peggio per la qualità della selezione dei quadri intermedi. L’unico vero leader viene distrutto dalla cultura del partito dominante (Renzi), ma soprattutto viene distrutto da una serie di aspiranti leader che sono addirittura brutte copie della stessa malattia. Quindi il partito è ostaggio di una serie di piccoli uomini, senza arte né parte, in perenne conflitto tra di loro, con gli stessi limiti dei loro concorrenti, semmai esasperati dal fatto che nemmeno sono in grado di vincere le elezioni per la mancanza di attrazione carismatica. Andrea Orlando, Dario Franceschini, Francesco Boccia, Peppe Provenzano sono figuranti che aspirano a essere leader con gli stessi mezzi dei Salvini e dei Grillo… e non lo saranno mai.
In sintesi, la personalizzazione del partito perseguita attraverso personaggi con nessuna valenza di competenze reali, non può che produrre l’assenza di idee e peraltro la scalata ai partiti così come li conosciamo da parte di persone competenti è assolutamente impossibile. Un circolo vizioso oggi non spezzabile. - Il terzo e più importante fattore che sta minando alla base il sistema dei partiti è la necessaria convergenza delle scelte di governo verso un sistema che è sempre più globalizzato e transnazionale. I vincoli dell’Europa su cui la parte deteriore di Lega e i primi Cinquestelle hanno costruito la “ribellione” demagogica sono ormai non modificabili (per fortuna), ma esistono anche vincoli più stretti che sono il debito pubblico, la globalizzazione e la sua evoluzione post-pandemica, la pandemia stessa.
Ne consegue che l’azione di governo è estremamente vincolante al di là della propaganda demagogica. Non solo vincolata, ma anche molto complicata per un numero esplosivo di vincoli di sistema non modificabili che rendono i soldi di finanza pubblica in primis, ma anche il loro utilizzo, immediatamente giudicati dai mercati che prestano denaro agli Stati e sono i primi “grandi elettori” di ogni governo al mondo.
Questi vincoli sono sgradevoli per i partiti che tentano in vario modo di sottrarsi alla stretta mortale che vincola la loro demagogia elettorale. Così Claudio Borghi e Matteo Salvini blaterano senza senso di lasciare l’Europa, i Cinquestelle vagano tra banchi a rotelle e reddito di cittadinanza come i famosi due neuroni nel cervello, mentre Letta e Provenzano vagheggiano una spesa sociale che la demografia e il debito rende assolutamente irrealistica. E poi arriva Mario Draghi che, analogamente a Wolf di Pulp Fiction, “sistema le cose” come ha fatto con l’elezione del presidente.
I vincoli aumenteranno di peso anno dopo anno dopo la sbornia del denaro facile da pandemia, dopo che il vero grande problema dell’occidente, cioè il calo demografico (in Italia è esplosivo), si farà sentire con mancanza di forza lavoro e costo di un welfare insostenibile, e dopo che le assurde spinte iconoclastiche sulla transizione ecologica non gestita getteranno in povertà vasti strati della nostra società europea, senza spostare nulla dell’emergenza clima visto che India, Cina e Sud-Est asiatico proseguono nel loro cammino autonomamente.
E ci sarà quindi un’ulteriore e progressiva disconnessione tra i partiti, che necessariamente promettono soluzioni di breve periodo palesemente inesistenti e demagogiche e la realtà. Una realtà che si rivelerà davvero molto difficile e richiede una transizione generazionale con la stabilizzazione demografica, energetica e anche finanziaria dopo anni di sbornia collettiva di breve periodo culminata con la pandemia.
Mi aspetto quindi ancora meteore rapide di personaggi che emergono, splendono una sola notte e poi spariscono rapidamente, con anche un carico di odio per le aspettative disattese.
Se il sistema dei partiti come lo conosciamo è molto disfunzionale alla corretta amministrazione dello Stato, quale può essere l’uscita virtuosa da questa palude?
La premessa doverosa è che sono assolutamente pessimista sull’ipotesi di realizzazione di una possibile uscita da questo circolo vizioso, se non nel medio termine, ma vale la pena almeno di proporla o configurarla, non fosse altro per ridurre il tempo di attesa verso quella che probabilmente sarà l’inevitabile evoluzione più avanti.
La premessa maggiore è che amministrare uno Stato è un compito complesso, forse il più complesso al mondo e che per definizione servirebbero persone di grandissimo standing, con cultura e capacità eccezionali e con la credibilità e la leadership che ne consegue. Il presunto rischio della tecnocrazia (agitato strumentalmente dai politici di professione), è in realtà contemperato dallo scrutinio continuo e pervasivo dei nuovi media e quindi il tema diventa come fare sì che i “migliori” e non i capi bastone di questo o quel partito amministrino la cosa pubblica.
Il processo potrebbe configurarsi come lo schieramento anche alle elezioni di “raggruppamenti” non organizzati come partito (e l’esperienza pessima dei Cinquestelle offre spunti di ottimismo per la capacità di spostare rapidamente elettorato) che identifichino ex ante una squadra di amministratori competenti e capaci fuori dal sistema dei partiti, che si presentino non come ideologici o peggio come formazioni personalistiche, ma come raggruppamenti di gestione con competenze e capacità. Una specie di lista di consiglieri di amministrazione coordinati da un amministratore delegato che diventa Presidente del consiglio.
Carlo Calenda è forse la persona che ha per primo concepito questo sistema con Azione e il risultato alle elezioni di Roma è stato nascosto e sottovalutato per convenienza del Pd e dai giornali, ma è stato eclatante.
Se l’anno prossimo si presentasse alle elezioni una lista non partitica, da classificare solo per convenienza “di centro riformista”, che indicasse non solo Draghi ma anche una squadra di Draghi senza i vincoli dei partiti (Speranza, Orlando, Franceschini e i residui dei Cinquestelle) composta da persone di altissimo standing, sarebbe il raggruppamento di maggioranza relativa perché raccoglierebbe i voti dei delusi dalla Lega, dai Cinquestelle, dal Pd stesso oltre che dai vari cespugli di centro che oggi esistono senza grosse speranze elettorali. Ma soprattutto raccogliendo i voti di chi oggi si astiene perché non si riconosce nei partiti.
La sciagurata riduzione del numero dei parlamentari e la ancora più sciagurata bocciatura del referendum costituzionale precedente sono vincoli di sistema da sfruttare, perché consentono di ridurre la difficoltà di trovare parlamentari (sono di meno) e rendono il rapporto tra esecutivo e Parlamento forse meno complesso di quanto sia stato in questa legislatura.
Quindi non più partiti ma raggruppamenti, anche a geometria variabile, con una squadra di governo identificata e competente. Questi raggruppamenti declinano una visione del paese con alcuni capisaldi che a mio avviso sono abbastanza chiari.
Europeismo, Atlantismo, controllo della finanza pubblica e riduzione graduale del rapporto tra debito e Pil, una spending review draconiana, lotta all’evasione fiscale, politica di stabilizzazione demografica come priorità assoluta, arretramento dello Stato dalla pervasiva inefficace presenza attuale e quindi sburocratizzazione dei processi amministrativi, drastica riforma della giustizia con chiara separazione dei poteri e limiti alle invasioni di campo a cui abbiamo assistito sgomenti in questi anni. Questi sono i cardini di un programma di governo su cui poi declinare la gestione graduale della transizione ecosostenibile e l’altrettanto necessaria (ma non immanente e aprioristica) transizione digitale.
A questi raggruppamenti bisognerebbe poi associare una rivoluzione copernicana nell’attrazione alla gestione della cosa pubblica delle migliori competenze. Oggi un talento uscito dall’Università molto difficilmente entra in politica, se non quando le strade per l’affermazione personale nella società civile sono chiuse (e quindi si applica una selezione inversa dei peggiori, peraltro palese nel curriculum della gran parte dei nostri politici attuali che non hanno potuto o saputo fare pressoché nulla nel mondo “normale”).
È evidente che difficilmente questo meccanismo possa cambiare nei prossimi dieci anni, quindi bisogna superare il problema attraendo alla gestione pubblica le risorse di grande talento non all’inizio della carriera, ma dopo un certo periodo e relativi successi nella società civile.
Ci potrebbero essere due proposte concrete di grandissimo effetto e, mi rendo conto, di grande radicalità ma con effetti abbastanza certi.
La prima è rendere la possibilità di ricoprire incarichi pubblici di qualsiasi tipo e natura nel tempo limitata a un massimo di 12 anni dal primo incarico ricoperto indipendentemente dalle interruzioni, salvaguardando il principio di continuità e apprendimento, ma negando vigorosamente la possibilità ai Salvini e ai Franceschini di turno di concepire la propria vita come il cavalcare incarichi pubblici per quarant’anni. Regola senza appello o eccezione e controllata da un authority apposita inflessibile, perché come dimostrato dai Cinquestelle quando si dichiara la regola va tutto bene, ma quando la regola inizia a mordere sulle persone… iniziano le eccezioni.
La seconda proposta è retribuire le persone che entrano in politica con la media dei compensi da essi stessi dichiarati nei cinque anni precedenti, con l’eccezione ovviamente dei redditi da capitale. Quindi chi entra in politica viene retribuito esattamente come nella media del suo compenso nel mondo privato senza alcun limite superiore (i vecchi attuali 240mila euro da poco riformati). In questo modo non si penalizza economicamente chi si sente di dare un contributo e nello stesso tempo si valorizza la qualità dei migliori nel mondo reale e non nel mondo virtuale della politica.
Insomma non si entra in politica per sfruttarne gli indubbi ed enormi benefici economici (pensiamo alla massa dei parlamentari Cinquestelle che ha conosciuto una stagione di cinque anni guadagnando l’equivalente di 200 mila l’anno cioè quasi 10 volte quello che è il loro “valore” sul mercato), e soprattutto si entra in politica perché competenti, non da incompetenti assurti improvvisamente a gestori di problemi complessi (Daniele Toninelli, Laura Castelli, ma la lista sarebbe lunghissima).
Le due proposte sono radicali e non passeranno mai in un contesto autoreferenziale, ma io penso sarebbero sostenute dalla maggioranza degli italiani in un contesto di crescente disaffezione dalla politica attuale.
Il giudizio degli elettori italiani sulla attuale politica è pessimo. A Roma alle elezioni suppletive ha votato tragicamente il 13 per cento degli aventi diritto. Metà degli elettori dichiara di non sentirsi rappresentato. Lo spettacolo offerto dalle elezioni al Quirinale è stato il peggio immaginabile. La qualità media degli attuali leader politici se applicata a un mondo reale fuori dalla politica non esprimerebbe assolutamente nessuna responsabilità vera. Sarebbero impiegati di medio-basso livello al meglio, con il massimo rispetto per le posizioni di impiego di basso livello che lavorano duramente e senza privilegi di sorta.
Sarebbe ora di finirla e smettere quindi di lamentarci se Salvini dice cose strampalate, se Conte parla e non si capisce cosa dice, se Provenzano propone di tassare extra Jeff Bezos perché ha avuto successo, se la Castelli confonde lo stock con i flussi, e mille altri esempi di scempio della cosa pubblica.
Per smettere di lamentarci, alle prossime elezioni nel 2023 che sono drammaticamente vicine dobbiamo cercare di votare qualcosa che non sia uno degli attuali fallimentari partiti, ma una “cosa” nuova con persone nuove e dimostratamente competenti e senza legami con una politica fallimentare che ha avuto un unico ruolo, vale a dire caricare i nostri pochi figli di un debito mostruoso che dovranno pagare per tutta la vita, allo scopo di distribuire soldi a pioggia nella speranza di perpetuare il proprio ruolo all’infinito. Un ruolo che la storia giudicherà come merita, ma che nel frattempo ha già fatto danni gravissimi e irreversibili.
Mandiamoli tutti a casa alla ricerca, ahimè per loro, di un lavoro vero che non avranno mai, invece di scegliere con la logica del “tutti ma non lui” non importa se “lui“ è Salvini, Grillo o Renzi. Con Draghi e Mattarella e dopo il triste recente spettacolo, forse è più possibile di quanto fosse fino alla scorsa settimana.
Articolo pubblicato su: https://www.linkiesta.it/

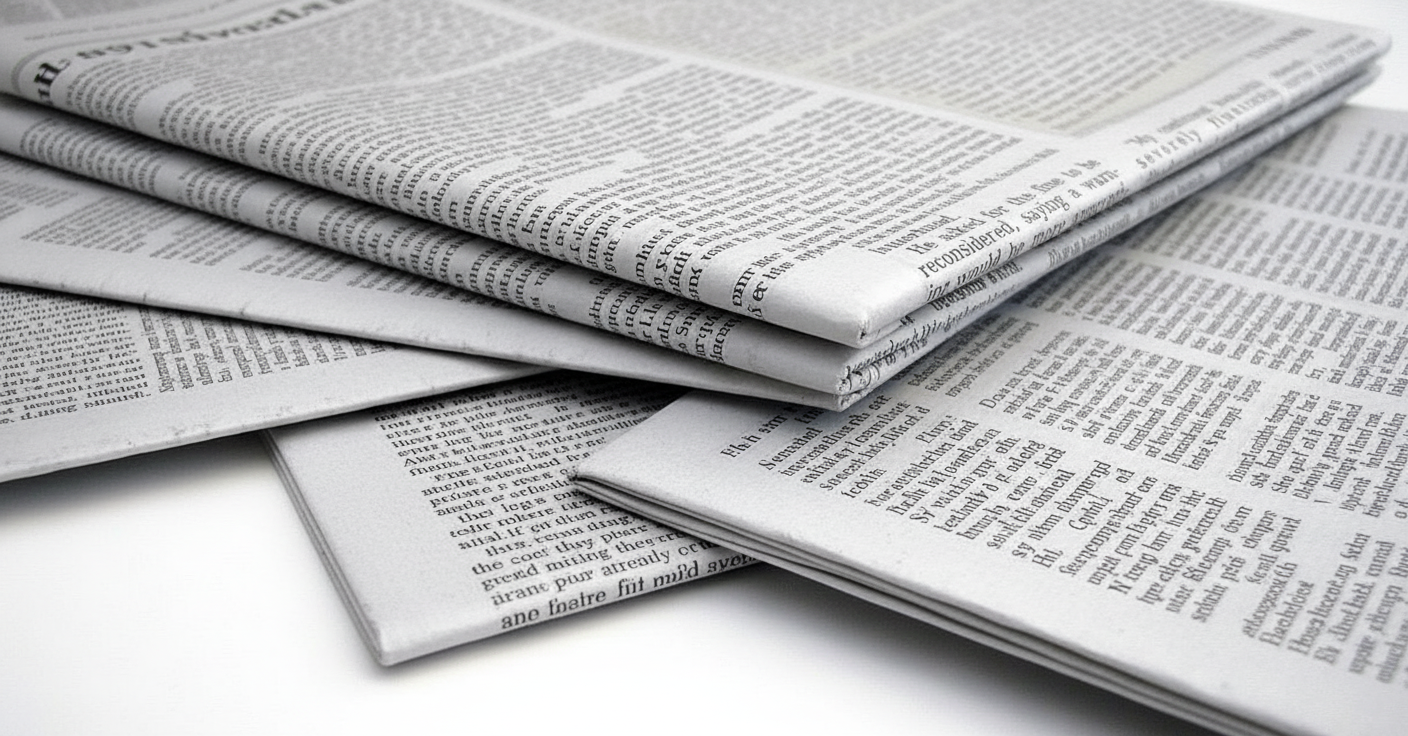
Giovanni Cagnoli
Cuba, Corea del Nord e Russia sono esempi plastici dei luoghi dove si vive peggio al mondo.
L’avvento di internet e delle comunicazioni planetarie rende impossibile la gestione della propaganda all’infinito.
E la capacità repressiva dei regimi totalitari sarà sempre più ridotta.
Quella a cui stiamo assistendo oggi è la coda della lotta durata quasi duecento anni tra una visione del mondo aperta, democratica, meritocratica con la possibilità per tutti i cittadini di scalare l’ascensore sociale, iniziata con la rivoluzione francese nel 1789 e quella americana del 1776, e il totalitarismo che si è realizzato in Europa e nel mondo come difesa del privilegio di pochi rispetto alle opportunità di molti.
Il totalitarismo prima di fine Ottocento era la regola assoluta, con modeste eccezioni (Atene del IV secolo avanti Cristo, Venezia). L’imperatore, il re, la nobiltà o il capo guerriero di turno, affermava con la forza, o con il diritto dinastico, il suo potere indiscusso. Un potere a tutto tondo economico, legislativo, militare.
Il contratto sociale con la popolazione si basava sul castello e sulla difesa di cui il re e i nobili si facevano paladini con un pesantissimo tributo di risorse umane e di lavoro da parte dei non nobili.
La rivoluzione industriale e la nozione che la difesa non poteva essere più basata sul castello e sulle mura (i cannoni li smantellano facilmente), così come il crescere del commercio tra nazioni e gli equilibri economici che ne derivano, hanno posto fine di fatto al modello monarchico, o nel XIX secolo ne hanno molto limitato i privilegi fino ad azzerarli nel XX secolo, e hanno fatto nascere una nuova categoria di privilegiati, cioè i detentori di capitale che emergevano in ogni società sviluppata, non più sulla base del diritto di nascita ma piuttosto sulla capacità di emergere.
Soprattutto le rivoluzioni liberali dell’Ottocento hanno diffuso il pensiero della possibilità dei popoli di autodeterminarsi attraverso una forma di democrazia che rifugge dalla scelta a priori dei leader. Non più il re, il capo guerriero o il dittatore, ma il primo ministro.
Il movimento marxista nato intorno al 1860 e trasformato poi in dottrina di Stato con la rivoluzione sovietica del 1917, non a caso fertile nell’unico Stato residuo dove i privilegi della nobiltà e dello Zar erano ancora ben saldi e quasi invariati rispetto a 150 anni prima, ha creato il residuo del totalitarismo nel XX secolo, insieme ai movimenti fascisti di Italia e Germania entrambi prosperati sulla base di una diffusa sensazione di ingiustizia per il privilegio economico del capitalismo coloniale anglosassone.
La Seconda guerra mondiale nasce da queste tensioni e in modo del tutto anacronistico, se non per la cartina geografica e le follie razziste di Hitler, vede su fronti contrapposti, i due totalitarismi (tedesco e russo).
Inevitabilmente la Germania con dimensioni economiche non paragonabili agli Alleati, e in più con un fronte russo geograficamente immenso, perde rovinosamente la guerra, ma vince in modo altrettanto eclatante la pace diventando la potenza economica dominante in Europa.
Un minuto dopo la fine della guerra appare chiaro che il totalitarismo comunista russo è il vero nemico dell’occidente liberale, Germania inclusa, e per 45 anni fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989, l’Europa dell’est si vede privata di libertà, crescita economica, progresso sotto il tallone del totalitarismo comunista.
Budapest nel 1956 e Praga nel 1968 rafforzano le convinzioni da una parte in Russia che l’unica risposta all’avvicinarsi di posizioni liberali sia l’invasione militare e dall’altra in Occidente che il comunismo sia non tanto una visione sociale moderna ma una efferata forma di totalitarismo ammantata e mascherata dal falso mito della filosofia egalitaria.
Nel XX secolo il crescere dell’importanza della dimensione economica delle società svela anche con una semplice analisi che il comunismo è un totale, incontrovertibile, duraturo fallimento economico e sociale.
Polonia, Cechia, paesi baltici dovranno attendere fino al 2030/40 per allinearsi all’occidente a cui appartengono per valori, cultura, istruzione e ogni altro parametro. Un anno di regime comunista ne costa due per riparare ai danni che provoca.
Quarantacinque anni di regime ne costano cento per riportare quei territori a uno standard di vita simile alla media europea.
Un’enormità e un costo tremendo.
Questa è la motivazione profonda della forza del sentimento anti-comunista in quei paesi davvero estremi.
Solo chi ha conosciuto il comunismo sa che è un costo sociale tremendo e lo combatte strenuamente, così come fanno oggi gli ucraini.
La democrazia e il liberismo lasciano spazio all’iniziativa individuale soffocata dal comunismo e in una specie di darwinismo sociale, a costo anche di generazioni perse, il mito del comunismo finisce con il crollo del muro di Berlino.
In Occidente purtroppo per anni è stata propinata solo per fini elettorali la bufala del buon comunismo, dimenticandosi gli evidenti aspetti del fallimento economico e del totalitarismo che ne erano intrinseci.
Ma il dato di fatto più interessante è un legame di continuità del comunismo o del totalitarismo in senso lato rispetto alla nobiltà del Settecento ante Rivoluzione francese.
Allo stesso modo, la nomenklatura comunista gode di privilegi incredibili rispetto alle masse, quanto la nobiltà nel Settecento rispetto alla borghesia e alla plebe.
Pochissime persone controllano economia, potere, media e sfruttano la promessa del comunismo o del nazionalismo, solo ed esclusivamente per proteggere in modo strenuo i propri privilegi.
Gli oligarchi russi di oggi con l’ostentazione della loro ricchezza, i gerarchi fascisti o nazisti di oggi, non sono altro che piccoli uomini violenti e aggressivi, assurti a un potere enorme, a privilegi di vita altrettanto enormi, che non vogliono per nessun motivo rinunciare a questi privilegi, per loro assolutamente irraggiungibili attraverso lavoro o ingegno.
Una volta acquisiti e “apprezzati” i privilegi, cercano di scovare una motivazione per le masse per evitare la rivolta popolare.
Motivazione che alternativamente può essere la mitologia del comunismo, o la difesa della nazione, o i soprusi delle altre nazioni. Ogni scusa è buona pur di non mollare i privilegi.
Soprattutto la minaccia di una rivoluzione liberale di successo come quella di Maidan del 2014 è terrificante.
Se l’Ucraina si fosse occidentalizzata con successo come sembrava accedere, come si poteva fermare la stessa evoluzione in Russia?
Da qui l’imperativo dell’invasione, non certo la Nato che, alleanza difensiva, non è una minaccia.
Ciò che minacciava, e lo minaccia a maggior ragione oggi dopo la sconfitta de facto dell’esercito russo, è l’impossibilità di invadere l’Ucraina in futuro, perché avrebbe definitivamente sancito la solitudine dell’esperimento totalitario di Putin e quindi in ultima analisi il suo fallimento economico, sociale e infine la rivoluzione.
Tra l’altro, geograficamente con l’adesione pregressa alla Nato dei paesi baltici, di Polonia e Romania non esiste più, a parte la piccola Moldavia, un territorio contiguo alla Russia dove fermare l’esperimento democratico.
La mia tesi è che nel mondo del XXI secolo la battaglia di questi tiranni privilegiati è senza speranza ed è l’ultimo colpo di coda nella storia.
Questo per 3 motivi fondamentali:
- L’avvento di internet e delle comunicazioni planetarie rende impossibile la gestione della propaganda all’infinito.
Russi e cinesi prima o poi vedranno in innumerevoli video le bombe su Kiev e la catastrofe umanitaria di Mariupol. E la reazione sarà rabbiosa. Un contadino francese nel Settecento aveva molte difficoltà a vedere lo sfarzo inutile di Versailles. Forse lo intuiva, ma di certo non lo vedeva tutti i giorni con infiniti dettagli. - Ugualmente il fallimento economico del totalitarismo è sotto gli occhi di tutti.
Cuba, la Corea del Nord, la stessa Russia tra pochissimo, sono esempi plastici dei luoghi dove si vive peggio al mondo e tristemente per i loro governanti anche la loro popolazione lo sa perfettamente, non fosse altro perché vede tutti i giorni quanto si vive meglio nel resto del mondo.
Vale anche per la Cina i cui governanti hanno però finora molto abilmente coniugato il più feroce totalitarismo politico con un altrettanto incredibile capitalismo economico selvaggio, e soprattutto non sembrano essersi enormemente arricchiti di privilegi anche attraverso una selezione di classe politica di tutto rispetto e capacità media probabilmente superiore all’occidente. - La capacità repressiva dei regimi totalitari è fortemente ridotta in epoca internet, sempre per effetto delle comunicazioni tra i repressi, e anche per l’impopolarità della repressione.
Alla fine Putin potrebbe essere costretto ad arrestare mezzo milione di persone che protestano e nemmeno lui lo può fare.
Quelli che non sono arrestati scappano e le migliori energie del paese se ne vanno determinando una spirale di impoverimento drammatico.
Succede alla velocità della luce in un modo dove trasporto di persone cose e idee è enormemente più facile che nel Settecento o nell’Ottocento.
Cinque milioni di profughi ucraini in tre settimane e code inenarrabili alla frontiera tra Russia e Finlandia ne sono dimostrazione evidente.
Quindi Putin ha già perso, semplicemente perché non può vincere. Non ha le motivazioni popolari, la struttura economica, la possibilità di controllo sociale per vincere. Crollerà tra 1, 2 o 5 anni ma crollerà travolto in modo violento dal suo stesso popolo e dai suoi oligarchi o dai suoi militari stanco di essere vessato, di vivere malissimo, di dovere emigrare. E chi dice che nella Russia profonda Putin è ancora popolare sottovaluta che le rivoluzioni si fanno sempre nelle città, Parigi o Bostonieri, San Pietroburgo o Berlino oggi, mai in campagna.
È altrettanto interessante il parallelismo di questa analisi con le vicende politiche occidentali dove abbiamo assistito alla creazione d’un ceto politico fortemente autoreferenziale, con privilegi meno enormi ma certamente marcati rispetto alla massa della popolazione, e con qualità per lo più modeste. È molto vero in Italia, ma anche in svariati paesi occidentali, dove il politico di professione è diventato fortemente impopolare proprio per i privilegi di casta, l’impermeabilità al cambiamento e la sostanziale evidente inversione tra i presunti fini (il bene del popolo) e i mezzi praticati (l’autoconservazione del proprio potere e privilegi).
La dimensione personale dei privilegi dei politici di professione è sottovalutata. Costoro vivono in un universo parallelo, con una serie di agevolazioni e privilegi personali, pagati dai contribuenti a cui, una volta provati, non sono più disposti a rinunciare per nessun motivo. L’immagine di Luigi Di Maio al telefono con autista nell’Audi A8 che mai e poi mai potrebbe nemmeno sognare con il suo lavoro è plastica. Così abbiamo assistito negli ultimi dieci anni a fenomeni di populismo democratico altrettanto pericolosi rispetto al totalitarismo. Chi si presenta alle elezioni dicendo «sono nuovo e diverso dai vecchi corrotti autoreferenziali» vince. Il claim elettorale è una bufala ovviamente, ma permette un giro di giostra al potere. Donald Trump, i Cinquestelle, Marine le Pen, Matteo Salvini e Boris Johnson (in una certa misura mitigato dalla centenaria tradizione democratica inglese) sono facce della stessa medaglia e cioè la proclamata vicinanza alle masse e alle istanze più becere delle masse, seguita da una gestione dissennata e pericolosa del governo del paese.
L’aspetto sorprendente ma non troppo, considerata la natura umana, è la facilità con cui costoro conquistano le masse. Bastano promesse e slogan ridicoli nella loro pochezza («abbiamo sconfitto la povertà» o «uno vale uno» o «make America great again») per vincere le elezioni spesso con un utilizzo spregiudicato della comunicazione digitale. Le masse vogliono credere alla soluzione magica e soprattutto diffidano delle élite politiche autoreferenziali in cui hanno visto corruzione diffusa, attaccamento pervicace alla poltrona e anche discreta incompetenza.
Ma il gioco per fortuna dura poco. I Cinquestelle spariranno tra meno di un anno dal panorama politico italiano, così come Salvini. Trump proverà a ripresentarsi ma a mio avviso (e su questo sono in minoranza) ha pochissime speranze di vincere e forse nemmeno di essere il candidato repubblicano, nonostante la pochezza culturale del Midwest e delle classi non educate degli Stati Uniti. Per fortuna, in democrazia i populisti spariscono, spesso con rabbiosa reazione, quando le masse si rendono conto che le promesse sono vuote.
Il costo però è molto elevato; ad esempio, in Italia il costo dei Cinquestelle sarà alla fine di cento o duecento miliardi a causa delle scelte scellerate (dai banchi a rotelle, al reddito di cittadinanza, alla guerra al TAP e ai rigassificatori e molto altro), un prezzo enorme per un paese molto indebitato e in crisi demografica. Forse proprio pensando al Midwest americano bisognerebbe riflettere attentamente su un paese (l’Italia) che dedica risorse al welfare pari a cinque volte quelle che dedica all’istruzione, dove peraltro le risorse sono spese per difendere l’assoluto opposto della meritocrazia per chi insegna e l’inutilità per chi impara. L’istruzione e lo spirito critico sono essenziali per la democrazia e noi stiamo facendo pochissimo per difenderla.
Restano però vive e vegete, soprattutto in Italia, le élite politiche che hanno esse stesse fortemente favorito la reazione populista. In Italia la sinistra ha governato per quindici degli ultimi venti anni pur avendo quasi sempre perso le elezioni, ha un personale politico uguale a sé stesso che di professione ha sempre e solo fatto politica, che non ha alcuna prospettiva di lavoro reale fuori dal Parlamento e dai ministeri e prospera adesso solo con lo slogan “mai con Salvini” riuscendo anche a digerire l’impresentabile Giuseppe Conte e i Cinquestelle nella speranza di restare al potere anche dopo le prossime elezioni.
La guerra scompagina però le carte in modo sensibile. I distinguo della sinistra identitaria italiana e dei Cinquestelle saranno indigeribili per un Pd riformista, atlantista ed europeista e quindi il sogno di Goffredo Bettini e Massimo D’Alema (quando non è distratto dalla vendita di armi ai colombiani) del campo largo viene spazzato via dalle bombe dei russi. Le stesse dichiarazioni sulla “pace che non si fa con le armi” stridono con il buonsenso e con la realtà. Andiamolo a dire agli ucraini sotto il fuoco nemico che la pace si fa con il dialogo.
Emmanuel Macron realisticamente vincerà ancora le elezioni francesi specie se al secondo turno andasse Marine Le Pen, Boris Johnson a breve sarà spazzato via dai suoi stessi conservatori, e Olaf Scholz in Germania sta riaffermando la migliore politica europea anche dopo Angela Merkel con un sano pragmatismo calvinista attento alle ragioni del benessere germanico, ma anche lontano dagli estremismi e dal populismo (il gas russo per noi purtroppo è fondamentale e ci vorrà tempo per smarcarsi).
Quindi, in sintesi, in Europa (ma anche negli Stati Uniti se la mia previsione sulla fine di Trump è corretta) la stagione del bipopulismo (di destra Le Pen/Salvini/AFD o di sinistra Cinquestelle/Linke) è sostanzialmente terminata, e avremo governi stabilmente di centro con uno spin di destra o di sinistra in funzione delle situazioni locali. Avremo, si spera, anche governi di competenti. Mario Draghi è il meglio che oggi l’Europa propone, un atout incredibilmente potente per l’Italia specie se non sarà condizionato dalla pattuglia di Cinquestelle e Lega che nel prossimo Parlamento sarà irrilevante.
L’esito delle elezioni italiane del 2023 invece è meno evidente e sarà uno spartiacque decisivo, visto che il peso dei bipopulisti (Lega e Cinquestelle) era il più alto in Europa, mentre manca un ancoraggio solido al centro che è maggioranza nel paese, ma allo stato attuale minoranza in Parlamento.
Sarebbe importante offrire alle democrazie occidentali e all’Italia in particolare, un meccanismo efficace per evitare i populismi nel tempo, e forse il modo migliore può essere garantire la capacità a un ceto politico non autoreferenziale di salire al potere. In questo senso la limitazione nel tempo degli incarichi pubblici (la stessa proclamata con enfasi sugli altri ma poi negata su se stessi dai Cinquestelle) a me pare l’antidoto più grande.
Nessuno potrebbe concepire di fare il politico a vita e questo cambierebbe drasticamente la possibilità di invertire fini e mezzi attraverso la politica. Così come la coscienza dei valori dell’occidente di libertà, auto determinazione e espressione individuale che questa guerra provocherà di certo, forse avvicinerà alla politica persone migliori, con maggiore esperienza di gestione amministrativa e senza l’attaccamento al ruolo tipico di chi non ha alcuna prospettiva fuori dalla politica (Di Luigi Di Maio e tutti i Cinquestelle, Salvini e molti nella Lega, ma anche molti nel Pd).
Ci sono segnali importanti in tal senso come Giorgio Gori, Beppe Sala, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Carlo Calenda, Stefano Bonaccini, Giovanni Toti, e in generale una classe di amministratori locali che per vincere deve amministrare e non solo fare promesse ai delegati del partito. Le elezioni del 2023 sono uno spartiacque importante in questo senso.
Di certo l’epilogo dei privilegi del re, del nobile, del gerarca, del politburo comunista, è molto vicino. Si tratta di non cadere poi nel privilegio del politico di professione che vessa certamente molto meno del dittatore, ma non ha le capacità e le competenze prima di tutto morali, ma anche tecniche e professionali per gestire la complessità dello Stato. La transizione è in corso e, anche nel mezzo della notte più buia per della democrazia, c’è motivo di essere fiduciosi, perché da sempre la natura umana vuole migliorare la propria condizione per lasciare un mondo migliore ai propri figli. Lo ha fatto con successo per migliaia di anni e non sarà un Putin qualsiasi a cambiare il corso della storia, anzi semmai catalizzerà alcuni processi che avrebbero richiesto più tempo per realizzarsi con successo.
Aspettiamo la sua fine con fiducia e combattiamo al meglio per difendere i nostri valori e per evitare che nuovi piccoli e grandi dittatori autoreferenziali arrivino ancora a propinarci le loro menzogne ammantate di ideali affascinanti e totalmente fasulli, irrealizzabili e costosi. Li abbiamo visti all’opera e basta così.
Articolo pubblicato su: https://www.linkiesta.it/

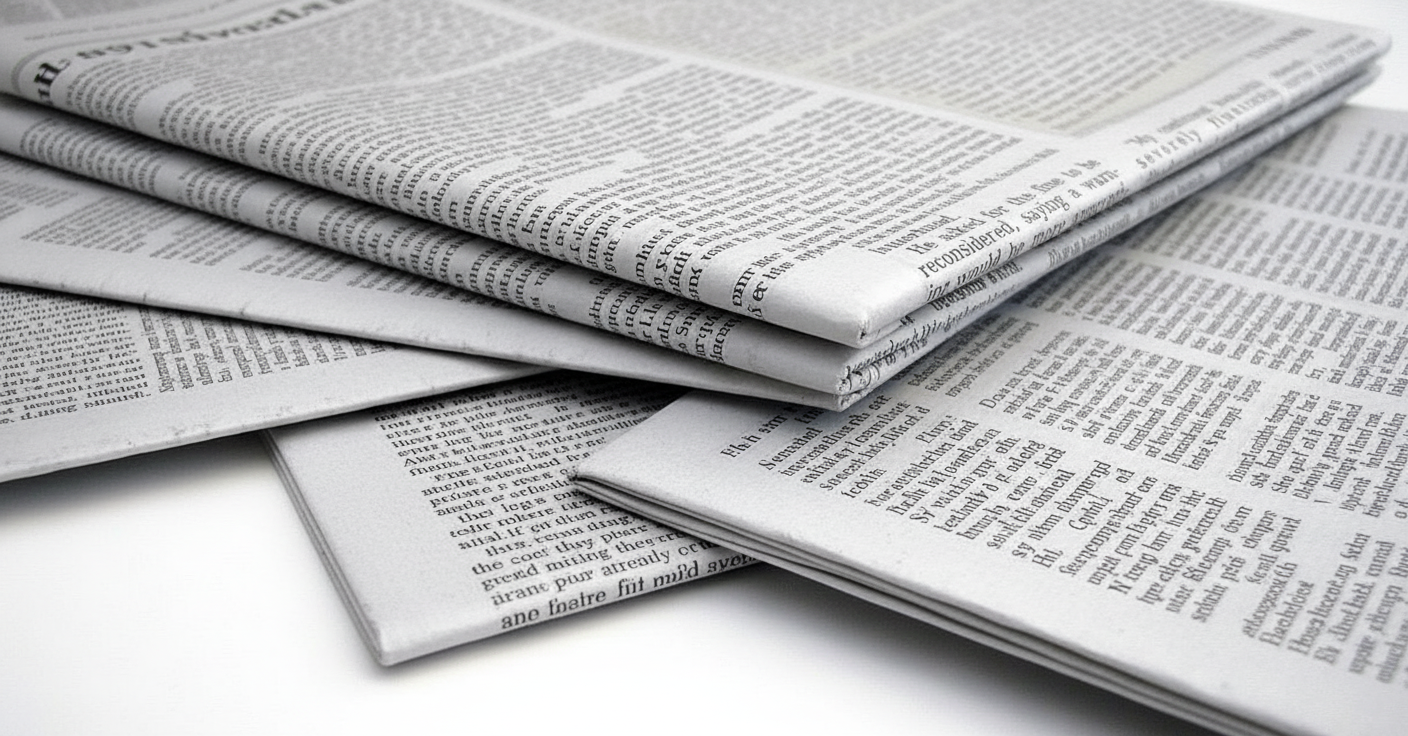
Giovanni Cagnoli
Siamo uno Stato pieno di diritti ma senza doveri, governato da una classe politica autoreferenziale che bada solo ai voti e alle elezioni successive. Adesso il governo ha l’assoluta necessità di dare una svolta, perché davvero questa è l’ultima occasione. Ma non lo farà. La manovra finanziaria del governo sarà un esercizio di mediazione tra le varie istanze di partito, personali, dei ministeri e infine anche di sindacati, stampa e partiti di opposizione. Si sceglierà di fare di tutto un po’, senza vere e proprie scelte nette di cui il Paese avrebbe disperatamente bisogno. Come sempre, anche durante l’ottimo governo Draghi, che doveva poi trovare approvazione dal Parlamento ampiamente popolato da un numero eccessivo di populisti di Cinquestelle e Lega, eletti nella peggiore tornata elettorale italiana, quella del 2018.
Questa mediazione di basso profilo è esattamente l’opposto di ciò che il Paese dovrebbe fare. Si deve finalmente scegliere perché la luna di miele dei tassi di interesse zero è finita, e non tornerà. Come è finita anche la possibilità di derogare dal percorso di rientro del debito pubblico, che con il Covid e per quattro anni (dal 2020 al 2023) non ha posto praticamente vincoli alla spesa, anche con i massicci acquisti di titoli di Stato della Bce, mentre adesso ritornano in auge le regole e i paletti di bilancio.
Come se questi due effetti già devastanti per le finanze pubbliche non bastassero, l’Italia ha anche l’eredità contiana del Superbonus centodieci per cento. Una follia pura e una serie di spese inutili e populiste che costeranno a tutti i contribuenti ben oltre cento miliardi di euro – sprecati in spese non solo gonfiate per i prezzi assurdi, ma anche spesso inutili in gran parte o semplicemente eccessive rispetto al valore, e per di più allocate a una fascia di popolazione che non ne aveva bisogno.
Non solo la stagione delle vacche grasse è terminata, ma adesso come sempre arriva l’epoca della carestia. La Germania è in crisi nera; la Cina si sta chiudendo nel modello statalista e dirigista dittatoriale che allontanerà investimenti e crescita; la svolta ecologista pone obiettivi irrealistici e costosissimi a carico della collettività e in più danneggerà pesantemente l’industria europea a vantaggio di Cina e India, che non faranno nulla o quasi se non approfittare della ritrovata competitività.
I nostri partner commerciali più importanti non aiuteranno, anzi forse porranno un freno alla nostra crescita economica per i loro problemi interni. Si aggiunga il devastante inverno demografico, che è peraltro solo all’inizio, e le prospettive di crescita del nostro Paese non sono rosee.
Sarebbe tempo di scelte, di scelte anche dure e impopolari, sarebbe tempo finalmente di mettere a mano all’assetto istituzionale che ha direttamente e pervicacemente impedito che queste scelte dure si facessero per oltre trent’anni dalla fine della Prima Repubblica. Ma non si vedono i presupposti politici o istituzionali perché ciò accada. La maggioranza è abbastanza solida e legittimata dal voto, ma non spicca per leadership, competenze e visione. E soprattutto è penalizzata dal pervicace populismo di Matteo Salvini e della Lega – pronto a sacrificare qualsiasi visione di lungo periodo per acchiappare un misero un per cento in più alle prossime elezioni –, e dalla progressiva involuzione di Forza Italia, che dopo Berlusconi non ha più alcuna capacità di incidere e tra poco si trasformerà progressivamente nel terreno di caccia elettorale degli altri partiti.
Giorgia Meloni ha stupito molti, ma adesso deve affrontare un compito arduo. Deve scegliere in un Paese che non è abituato alle scelte, ma ha sempre preferito il compromesso rimandando il problema. Un Paese che preferisce sempre l’oggi rispetto alle generazioni future, che privilegia vecchi e danneggia i giovani, che non investe ma consuma lentamente la sua ricchezza e il suo benessere, senza porsi mai il problema se questo sia sostenibile.
Non è direttamente Meloni il problema, ma l’incapacità collettiva della nostra opulenta società decadente di massa di affrontare la realtà. Il problema di Meloni è che governa lei, e sarebbe suo compito affrontare dopo tanti anni questa emergenza.
Quali sono le scelte più difficili?
Piuttosto che dire a chi diamo soldi con la finanziaria, bisogna affrontare l’annosa scelta di segnalare a chi togliamo risorse dello Stato, dal momento che mancano soldi per i motivi evidenti sopra menzionati. E scegliere a chi togliere non è mai stato fatto se non in modo surrettizio e non trasparente. Soprattutto, andrebbero evidenziate in modo netto le scelte redistributive tra categorie di persone diverse, anche a costo di scelte dolorosissime ma necessarie.
Lo Stato italiano intermedia circa ottocento miliardi di entrate fiscali con ottocentoottanta miliardi di spese. Il saldo è grosso modo il deficit che accresce il nostro debito pubblico e che deve lentamente andare a zero, o quasi. Le entrate sono molto difficilmente aumentabili per un carico fiscale ai limiti superiori in ogni confronto internazionale. E anche banalmente calcolando le imposte pagate dai 2,4 milioni circa di italiani (il quattro per cento della popolazione totale) con un reddito dichiarato di oltre cinquantamila euro, che sostengono il quaranta per cento del carico fiscale (sic). La storica narrazione della sinistra bertinottiana, molto cara oggi a Elly Schlein, «facciamo piangere i ricchi» si scontra con questo dato di fatto. Il quattro per cento paga il quaranta per cento. E forse pensare che quei 2,4 milioni di persone sostengano l’onore dell’aggiustamento della finanza pubblica sembra onestamente un po’ azzardato anche per le menti belle della sinistra.
Ma la scelta di dove spendere invece una cifra enorme, cioè ottocento miliardi circa al netto degli interessi, che non sono sindacabili, andrebbe fatta subito e chiaramente. E purtroppo andrà prima o poi fatta la scelta di dove non spendere, scegliendo tra categorie che rappresentano voti, interessi, numerosità ma anche prospettive di sviluppo, etica e giustizia sociale molto diverse tra di loro.
Giovani contro vecchi
L’Italia è un Paese di anziani con il welfare più generoso del mondo. La spesa per pensioni e welfare è superiore in percentuale sulle entrate fiscali complessive al trentacinque per cento. La crisi demografica farà sì che un numero decrescente di lavoratori debba pagare il welfare di un numero crescente di pensionati. Non ci vuole un fine matematico per capire che i trecentottantacinquemila nati nel 2023 saranno oberati di tasse per pagare le pensioni di novecentoventimila nati negli anni tra il 1960 e il 1970. Ogni lavoratore nato nel 2023 dovrà sostenere il peso del welfare di circa 3,5 persone nate tra il 1960 e il 1970.
Quindi si deve scegliere se mantenere il livello di welfare attuale, tassando in modo esponenziale i giovani, oppure fare ciò che in Italia non si può nemmeno pensare o scrivere, cioè tagliare il welfare. Lo slogan «le pensioni non si toccano» si deve accompagnare con la diretta conseguenza «tassiamo di più chi lavora». Tertium non datur.
Qualcuno poi dovrebbe spiegare perché nel mondo del lavoro l’indicizzazione dei redditi all’inflazione dipende giustamente dalla capacità competitiva delle imprese di sostenere costi più alti o attrarre lavoro più qualificati con salari superiori, mentre i ventuno milioni di pensionati ricevono indiscriminatamente una indicizzazione pari al cento per cento del tasso di inflazione il 1° gennaio di ogni anno. È proprio così impossibile limitare o azzerare l’indicizzazione oltre un livello molto basso di pensioni mensile?
Invece Salvini lotta per aumentare il welfare con pensioni anticipate e quota 103 e altre diavolerie. Evita però di dire che questo comporta più tasse per i giovani, anche se il nesso causale tra le due scelte è palese ed evidente, contando sul fatto che il numero di pensionati e assistiti supera, e sempre di più lo farà nei prossimi anni, il numero di lavoratori.
Ci hanno propinato per anni e per cultura catto-comunista il divario tra ricchi e poveri. Il vero drammatico divario di questo Paese è tra chi è nato grosso modo prima del 1980 e chi è nato dopo. E finora, pervicacemente, malevolmente e senza ritegno tutte le scelte di politica economica e fiscale hanno favorito gli anziani e per converso penalizzato i giovani, senza che nessuno, ma proprio nessuno, levasse una voce per fermare lo scempio.
Lavori esposti alla concorrenza e lavori “protetti”
Esistono una miriade di lavori protetti in Italia, lavori non esposti alla concorrenza che godono di privilegi assurdi. Non parlo del pubblico impiego in sé o in toto, anche se molti lavori “protetti” esistono certamente anche nel pubblico impiego. Parlo della burocrazia improduttiva che una sequela di governi statalisti prevalentemente di sinistra ha imposto al Paese. Il numero di “controllori”, sovrastrutture burocratiche, regolamenti a cui le imprese sono sottoposte non ha senso. Tutto si basa sulla nozione che lo Stato deve essere pervasivo nel permettere, regolare, chiedere informazioni, multare, in qualche modo ostacolare l’iniziativa privata che è a priori ritenuta potenzialmente truffaldina, sregolata e in qualche modo da limitare. Una visione statalista e burocratica che ci costerà moltissimo in termini di tenore di vita e di benessere senza apportare vantaggi evidenti sul fronte della limitazione degli abusi (che è sacrosanta).
Un’azienda oggi in Italia deve remunerare il collegio sindacale, i revisori, le strutture per la 231, per la 626, adesso anche per il whistleblower – cioè la necessità di ascoltare chiunque abbia a segnalare irregolarità all’interno dell’azienda, redigere il bilancio verde, studiarsi una legislazione fiscale che rivaleggia in estensione verbale con l’enciclopedia Treccani, farsi carico di una serie di leggi e regolamenti che aumentano ogni anno e comportano costi ed esborsi.
Si devono trasmettere dati all’Inps, alla camera di commercio, all’Istat, dati che lo Stato ha già e riceve già in formato elettronico, ma che chiede due, tre o quattro volte perché ogni ente che chiede può impiegare strutture di governo scelte essenzialmente dai partiti (camere di commercio ad esempio) e quindi esercitare potere, sottogoverno e produrre costi diretti e indiretti nelle aziende.
Un esempio tra mille. I cedolini fiscali delle buste paga sono a disposizione dell’Inps ogni mese e contengono tutte le possibili informazioni su sesso, età, stipendio, contributi e quant’altro. Che bisogno c’è di chiederle altre due volte (Istat e UnionCamere) con moduli di venti pagine da riempire con annessa sanzione in caso di non adempimento? Il bisogno vero è nominare presidenti, vicepresidenti, consigli di amministrazione e migliaia e migliaia di posti di sottogoverno per lo più clientelari che portano voti.
Un altro esempio. Ci sono in Italia circa ottomila comuni di cui milleottocento circa con meno di mille abitanti, cioè circa il ventitré per cento. In questi milleottocento comuni vive meno del due per cento della popolazione. Poi ce ne sono altri tremilacinquecento circa tra mille e cinquemila abitanti. Esiste una legge che favorisce accorpamenti che non ha dato risultati tangibili. Possibile una decisa azione coercitiva?
Un ultimo esempio. Ci sono in Italia circa ottomila società, enti di diritto pubblico a carico dello stato per risorse e spese. Io penso che almeno quattromila siano del tutto ridondanti se non dannose. Un governo di legislatura potrebbe darsi un obiettivo su tre anni, comunicare ogni trimestre i risultati e attraverso liquidazioni, accorpamenti e fusioni o scioglimenti raggiungere il dichiarato obiettivo di dimezzare il numero. Ogni società ha un presidente rispetto al dichiarato (remunerato), un cda (remunerato), una sede e una struttura di governo che costa. La percentuale di spesa che va effettivamente allo scopo sociale è spesso inferiore al cinquanta per cento.
I recipienti di questi costi sono i “protetti”, cioè coloro che prosperano in enti o società o strutture parasociali senza alcuna concorrenza, la cui necessità è stabilita per legge, la cui tariffa è de facto stabilita da un monopolio o una corporazione e la cui produttività è sostanzialmente zero, nel senso che non contribuiscono alcunché alla generazione di valore aggiunto. Progetto di riduzione alla metà e ogni tre mesi conferenza stampa con i risparmi ottenuti.
Nel Paese del collegio sindacale, della revisione dei conti, della 231 sono successi tranquillamente Cirio, Parmalat e Monte dei Paschi di Siena. C’è chi sostiene che senza la miriade di regole, regolette e regolette molte di più sarebbero stati i casi di evidente malversazione societaria, ma personalmente ritengo all’opposto che regole meno costose ma più penalizzanti (es. interdizione a vita da qualsiasi carica o attività economica indipendente, in caso di conclamata colpa o dolo estesa anche al consiglio di amministrazione in carica) potrebbero avere più effetto con molti meno costi.
I lavori “protetti” sono in molti territori (al Sud specialmente) gli unici disponibili, ma il costo sulla competitività di questa tassa occulta è abnorme.
Corporazioni contro collettività e libero mercato
Da anni sentiamo parlare di «liberalizzazioni» (le lenzuolate di Pier Luigi Bersani fanno sorridere se si è molto di buon umore, però, in caso contrario, domina la rabbia per la presa in giro), ma non succede mai nulla. Prendere un taxi a Milano o a Roma quando piove è un’impresa titanica. Ma non si possono dare nuove licenze pena il blocco totale della città. La vicenda Alitalia, dove dodicimila lavoratori hanno tenuto in ostaggio un intero paese per vent’anni costando circa dieci miliardi alla collettività, cioè poco meno di un milione di euro a testa (oltre al loro stipendio), è tristemente nota.
Il costo di un atto notarile è probabilmente il più alto al mondo e va a vantaggio di una corporazione di 5143 persone con il reddito medio più alto in Italia. Utilities, farmacisti, librai (con i libri di scuola), certificatori e asseveratori di tutti i tipi (che poi non hanno mai alcuna responsabilità se la certificazione risulta falsa, vedi il caso del centodieci per cento), e in generale tutte le categorie che svolgono attività che godono di prezzi o quantità o regolamenti che escludono la concorrenza e vengono imposti dallo Stato, sono una tassa occulta per tutti noi.
Dall’altra parte ci sono essenzialmente le imprese soggette a concorrenza internazionale che invece vendono e sopravvivono solo se hanno capacità di essere sempre costantemente competitivi. Se il pezzo o la qualità del prodotto non è adeguata si fallisce o si chiude. Questa è la dura legge del mercato per chi sta sul mercato davvero.
Se però il peso dei beni e servizi delle corporazioni supera il lecito lentamente il Paese non cresce più, anzi decresce perché in altri Paesi si è generalmente più competitivi. Ed dove si è più competitivi si investe di più, allargando il solco in modo progressivo e inesorabile.
Però scardinare i privilegi delle corporazioni in un Paese dove tassisti, agricoltori, le cooperative e i loro privilegi incredibili, o qualunque tipo di corporazione può bloccare la convivenza civile è praticamente impossibile. Quasi nulla è stato fatto in trent’anni, e anzi molte corporazioni si sono rafforzate a scapito della collettività.
L’impatto di tutto questo sulla crescita del Paese è stato semplicemente strabiliante, in negativo. Dal 1990 al 2022 se si calcola la media di incremento annuale del Pil, l’Italia è al penultimo posto al mondo con una crescita del ventotto per cento in trentatré anni (fonte: Banca mondiale). Peggio di noi ha fatto solo l’Ucraina, che nel 2022 ha avuto la guerra e nel 1990-94 ha perso il quaranta per cento del Pil dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il Pil non è la felicità e siamo tutti d’accordo, ma col Pil si paga il welfare, la sanità, l’istruzione e adesso dovremo pagare anche la difesa visto che gli Usa sembrano meno propensi ad assumersi il cento per cento dell’onere e qualcuno molto vicino a noi sembra essere molto aggressivo ai limiti del pericoloso.
Siamo ultimi al mondo, senza se e senza ma. Ci sarà un motivo o qualcuno pensa che sia solo sfortuna? Senza Pil bisogna ridurre il tenore di vita, non ci sono altre soluzioni in ambito europeo e con un debito già troppo elevato e quindi da ridurre.
Per far crescere il Pil servono investimenti, produttività, deregolamentazione, istruzione e ognuna di queste attività richiede ingenti risorse che vanno prese da altre spese meno produttive. Non abbiamo scelta e questa finanziaria (così come le prossime tre finanziarie purtroppo) – devastata dall’ineffabile Giuseppe Conte con il suo scellerato super bonus – è la prima che presenta il conto dopo che nel 2020 e 2021 c’era il “liberi tutti” da Covid e nel 2022 l’effetto della regalia di Stato e il confronto con il disastroso 2021 ha nascosto tutti i problemi.
Da adesso in avanti si può solo stringere la cinghia, ma se continuiamo a sprecare arriverà anche il digiuno. Inesorabilmente.
Le scelte sono perciò non più rimandabili e per definizione dovranno anche essere dolorose. Scegliere vuole dire scontentare qualcuno, non accontentare (apparentemente) tutti. Il dibattito però oggi è sul salario minimo e non ci si rende conto che per i due terzi del Paese (che produce però l’ottanta per cento delle entrate fiscali e il novanta per cento dell’export) il problema non è il salario minimo, bensì drammaticamente la mancanza totale di offerta di lavoro – lavoro vero con contratti ben superiori a nove euro l’ora per capirci. Mancano persone e mancheranno drammaticamente di più anno dopo anno, con l’ovvia e assolutamente auspicabile conseguenza che i salari saliranno e anche molto nei prossimi anni. Alla faccia del salario minimo di qualsivoglia importo.
Oppure si dibatte sulla scuola e nessuno si preoccupa di analizzare quali siano le conseguenze sugli organici e le strutture del passaggio (che è già certo) da seicentomila nati quindici anni fa a trecentosessantamila nati nel 2025. Qualcuno ci sta pensando? Perché succede con assoluta certezza e tra sei anni in prima elementare ci andranno sei bambini su dieci rispetto a quindici anni fa. Numero di insegnanti identico, quindi per definizione o erano troppo pochi quindici anni fa o saranno troppi tra cinque anni. Quale delle due ipotesi è vera? Se ne può parlare?
Oppure si dibatte sui diritti, ma mai nessuno parla di doveri, perché parlare di doveri non porta voti, mentre evocare un mondo pieno di diritti perché «c’è lo Stato» è più bello. Basta riascoltare Conte quando diceva orgoglioso «rifatevi la casa, tanto paga lo Stato, capite?». Un esempio fulgido di statista. Abbiamo dato il diritto a rifarsi la casa agli italiani. Un successo tutto e solo nostro nel campo dei diritti. Campo già ampiamente popolato nel nostro Paese.
Questo Paese ha incredibili risorse e ha un potenziale straordinariamente grande, inespressamente soffocato da trent’anni di cattiva gestione politica. Non è sensato che a breve saremo il fanalino di coda dell’Europa appena davanti alla Grecia (che incidentalmente adesso sta crescendo benissimo governata in modo corretto e dopo una crisi devastante e una povertà davvero diffusa), appena davanti alla Spagna che non ha nemmeno per sogno una struttura industriale, manifatturiera e di export paragonabile alla nostra. Eppure, i dati dicono questo. A breve tutta l’Europa dell’est avrà Pil pro capite superiore al nostro, la velocità con cui tutti i paesi dell’Europa balcanica e orientale stanno crescendo è impressionante.
Non siamo più stupidi e non siamo meno dediti al lavoro dei polacchi o degli sloveni o degli spagnoli. Siamo solo stati governati molto molto peggio da una classe politica autoreferenziale, che aveva l’unico obiettivo di tenere fuori Silvio Berlusconi e perpetuare il proprio potere. O siamo stati governati da Berlusconi stesso, per pochi anni: evidentemente non ha realizzato molti dichiarati obiettivi oltre alla protezione del suo impero. Poi sono venuti i Cinquestelle e lì si è consumata una vera e propria sciagura nazionale, con la sagra dell’incompetente che governa (vengono alla mente altri aggettivi poco appropriati), Conte primo fra tutti, per quattro anni.
Questo governo non ha l’occasione ma ha l’assoluta necessità di iniziare a dare una svolta, perché davvero è l’ultima occasione. La prognosi non è per nulla benevola visto l’insieme delle competenze espresse, ma abbiamo sempre stupito noi e il mondo con la nostra capacità di superare le prove più incredibili. Il benessere e il tenore di vita dei nostri figli dipendono essenzialmente dai prossimi 3-5 anni. Dopo sarà ahimè troppo tardi e dovremo rassegnarci, in mancanza di notevolissimi cambiamenti, a un lento inesorabile, fastidiosissimo declino.
Io ho fatto di tutto, in parte non riuscendoci, per convincere i miei figli a restare in Italia, nonostante le sirene del lavoro in altre nazioni fossero forti e chiare. Ho sempre pensato e sostenuto con loro che questo Paese, pur con mille difetti, sia il più bello al mondo, dove si incontrano persone splendide che lavorano, innovano, si impegnano a costruire un mondo migliore ogni giorno e ci sono riusciti realizzando imprese uniche al mondo, bellezza, fascino ed esperienze di vita invidiate da tutto il mondo.
Non vorrei mai che i miei figli dicessero ai miei nipoti attuali e futuri che non c’è nulla da fare e che quindi è bene che se ne vadano altrove per realizzare al meglio i loro talenti. Sarebbe una cocente sconfitta per me e per la mia generazione. Ma se non facciamo nulla oggi e subito, temo che sia una prospettiva molto probabile e molto molto triste.
Articolo pubblicato su: https://www.linkiesta.it/

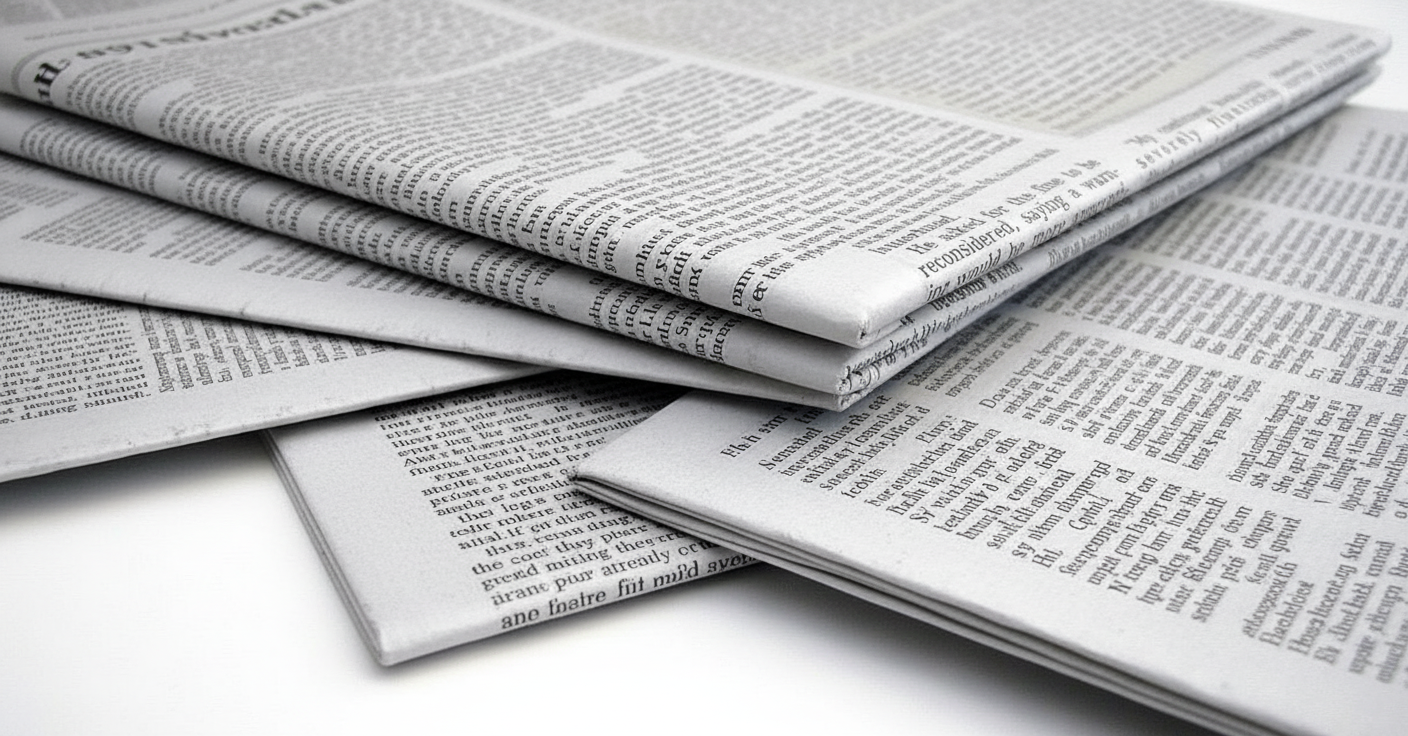
Giovanni Cagnoli
Bruxelles deve imparare a reagire all’aggressività russa e cinese. Le sfide dei prossimi decenni richiedono la presenza di veri statisti, che sappiano indirizzare con fermezza la politica comunitaria in materia monetaria ed energetica. Le elezioni europee hanno fatto emergere alcuni grandi e forse nuovi problemi (voto in Francia, carenza di leadership diffusa) senza risolvere nessuno dei grandi temi che sono di portata generazionale per l’Europa. La cifra comune è l’assenza di veri statisti e, all’opposto, la crescita elettorale di populisti e demagoghi che determinano una specie di blocco totale nell’affrontare le sfide che ci attendono, trasformando la contesa politica in una sfida al ribasso. Siamo di fronte a una serie di temi cosiddetti identitari che magari catturano l’attenzione dei media e fanno notizia di breve termine, ma che pochissimo hanno a che vedere con la società in cui vivremo tra dieci anni, le cui basi si mettono invece oggi in un momento di grandissima transizione e spostamento di potere geopolitico.
I fatti nuovi che non vengono affrontati sono numerosi:
- La necessità di difendersi dall’aggressività militare della Russia (e della Cina in prospettiva), che non sono disponibili allo status quo di dominio economico dell’Occidente e utilizzano il potere militare e il deterrente atomico per aumentare la propria sfera di influenza. Ne discende, anche per effetto della sciagurata dottrina trumpiana, la necessità di spendere risorse maggiori sulla difesa del continente direttamente minacciato dalla Russia, che è peraltro confinante, aggressiva e guidata da un dittatore senza scrupoli e fortemente nazionalista.
- La crisi demografica che inizia a fare sentire i suoi effetti con un impatto negativo sull’economia, una forte e crescente pressione al rialzo dei salari, e la necessità di affrontare inevitabili spinte migratorie senza avere gli strumenti necessari per l’integrazione sociale. La vicinanza geografica dell’Africa, unico continente con pressione demografica ancora esplosiva, rende il tutto ancora più complicato.
- Il cambiamento climatico (le cui portata è ancora da definire) e la spinta alla transizione verde comportano un costo abnorme e una disparità di competitività con sistemi Paese (Cina e India soprattutto) che in larga misura determinano l’impatto complessivo delle emissioni sul pianeta, ma che non si accollano, se non in minima misura, i costi della transizione ecologica. Per contro, l’Europa spinta da movimenti politici senza alcuna capacità di visione, ma solo da modesto populismo identitario, sopporta costi giganteschi, con risultati del tutto trascurabili in ottica globale.
- L’impatto dell’intelligenza artificiale, ancora poco chiaro per tempistica di realizzazione e portata, può trasformare in modo duraturo le modalità di lavoro, il mix delle competenze necessarie e in generale tutto il mondo delle imprese. Gli Stati Uniti sono enormemente avvantaggiati per le risorse che le “magnificent seven” (Google, Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon) hanno accumulato, e quindi stanno investendo, e si rischia di essere colonizzati economicamente sulla base di investimenti finanziari che già oggi non sembrano alla portata del sistema Paese Europa.
- In generale, il riflusso della globalizzazione, conseguenza delle due guerre in corso (Ucraina e Medio Oriente), ha un impatto sproporzionatamente alto sull’Europa, che ha goduto per anni dell’accesso a esportazioni sostanzialmente libere e che si trova ad affrontare invece in modo durissimo un mondo dove forse le materie prime saranno usate per scopi geopolitici (il gas di Putin nel 2022) e dove forse i rapporti di libero scambio saranno sconfessati alternativamente da sussidi enormi (le auto elettriche cinesi ma anche i chips americani) o alternativamente da dazi insostenibili. L’Europa, che ha il massimo grado di apertura all’import/export, è destinata a pagare un elevato prezzo di inflazione o minore crescita (o recessione) a queste dinamiche ormai evidenti.
A fronte di questi problemi, davvero da fare venire i brividi, ci troviamo a discutere i raggruppamenti dei sovranisti, la leadership di Ursula von der Leyen, i posti nel governo europeo secondo un manuale Cencelli di sapore stantio, la posizione e i veti di un Paese come l’Ungheria che ha il Pil inferiore a quello del Veneto, e una serie di altre amenità di pochissimo impatto, quali le dimissioni di Enrico Letta da Sciences Po o il posto di Raffaele Fitto nella Commissione europea.
La crisi è conclamata quando mancano in tutta Europa statisti e politici di livello, mentre nei Paesi più grandi e trainanti c’è un presidente semi disperato (Emmanuel Macron) che convoca le elezioni generali, ben sapendo di perdere, ma nella speranza di sfruttare il sistema elettorale per bloccare i sovranisti; un leader azzoppato e senza alcun seguito (Olaf Scholz) che, dopo avere rallentato l’aiuto all’Ucraina per oltre un anno, non sa più cosa fare se non aspettare la fine di un ignominioso mandato di governo in cui ha rallentato e azzoppato l’intera economia tedesca come non si vedeva da decenni; una serie di leader minori (Belgio, Olanda, Spagna) con maggioranze raffazzonate o labili che non contribuiscono a creare la possibilità di discutere una seria agenda di riforme e di sviluppo.
Meglio non stanno, anzi direi che stanno peggio: il Regno Unito dove riemerge dal nulla Nigel Farage e viene accreditato di un venti per cento di consenso nonostante abbia mentito in occasione del peggiore errore di valutazione della storia con la Brexit; negli Stati Uniti, Trump ha buone probabilità di essere eletto nonostante la condanna in un processo e le imputazioni in numerosi altri, ma è chiaramente inadatto per carattere, onestà e senso dello Stato a guidare la più grande democrazia del mondo.
Paradossalmente (rispetto al passato almeno, non certo per demeriti strutturali), l’Italia esprime forse il maggiore statista della nostra epoca nella persona di Mario Draghi, e un governo Meloni che dimostra (contro ogni previsione dell’opposizione) un ancoraggio europeista, un discreto pragmatismo e la capacità di portare avanti alcune riforme lungamente attese (la riforma giudiziaria e il migliorabile premierato). Tutto ciò nonostante l’azione continua di disturbo dell’alleato Matteo Salvini che non perde occasione per danneggiare la propria base elettorale in ogni modo immaginabile (dal ponte di Messina, alla grottesca autonomia, alla versione sbiadita del nazionalismo de noantri di Roberto Vannacci).
Peraltro, in tutta Europa, ma soprattutto nell’opposizione di sinistra minoritaria ma sempre molto vocale e maggioritaria nei media, hanno ancora ampio eco temi identitari sicuramente interessanti, ma certo meno importanti delle sfide che ci attendono. I diritti delle minoranze Lgbtq+, il pacifismo in epoca di aggressione esterna, lo ius soli in epoca di immigrazione difficilissima da integrare, la transizione verde “a prescindere”, adesso il diritto alla casa (di proprietà o espropriata non si distingua troppo), il diritto allo Stato palestinese dopo un massacro premeditato di oltre millecinquecento israeliani, sono temi tutti probabilmente giusti o seri, ma hanno il grave difetto di distogliere l’attenzione e il focus dagli altri temi che a mio avviso sono drammaticamente più rilevanti e urgenti.
La sindrome di “sì ma anche” è spesso associata alla decadenza di un sistema sociale che non sa più riconoscere l’istinto alla sopravvivenza ancorché gravemente minacciata, proprio perché, dopo tanti anni di benessere considera acquisite conquiste che invece sono gravemente a rischio e si concentra su temi appunto identitari e non di sopravvivenza. Riflettiamo semplicemente quanto ognuno di questi temi citati sia di interesse nei due sistemi Paese (Russia e Cina) che per motivi diversi sono aggressivi nei confronti dell’Occidente, e dopo avere riflettuto brevemente su quanto il partito comunista cinese sia attento a Lgbtq+, ius soli, immigrazione, transizione verde, pacifismo e altre “battaglie identitarie”, chiediamoci se abbiamo davvero le risorse per resistere alla minaccia chiarissima che ci viene dall’esterno se scegliamo di concentrare le nostre migliori risorse su questi temi e non su altro.
Si obietterà che non sono in contraddizione, ma invece io penso che ogni afflato riformatore o di cambiamento abbia per sua natura un’intrinseca difficoltà realizzativa, come ben sanno i migliori capi azienda. E disperdere risorse, attenzione e volontà politica su questi temi può forse raccogliere voti, ma riduce la prosperità delle prossime generazioni. Saremo di certo più armocromatici, ma anche terribilmente più poveri e con meno risorse da dedicare alla difesa dei valori fondamentali della nostra società, che sono le libertà personali di pensiero, espressione individuale, di impresa, di associazione e di voto.
Le scelte vere e importanti invece sono altre e diverse. Noi abbiamo risorse limitate, come ogni sistema sociale, e dobbiamo scegliere a quali temi vogliamo dedicarle. Le grandi categorie sono il welfare che con la nostra demografia è una bomba a orologeria già innescata, la difesa dove forse non basterà il famoso due per cento del pil, l’istruzione che sarà sconvolta dall’impatto dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo economico dove dovremo tornare a difendere i nostri vantaggi competitivi ben sapendo che gli “altri” fanno lo stesso da anni e con grande spregiudicatezza, e infine la coesione sociale.
Trascurando per un attimo l’ultimo problema, che ha più a che vedere con una riflessione valoriale e filosofica della coesione sociale in un’epoca di informazione (e disinformazione) rapidissima veicolata dai social media, a me pare che dovremo necessariamente porci il problema prioritario dello sviluppo economico per rendere disponibili le risorse necessariamente crescenti per il welfare in un’epoca di declino demografico, di aumento delle spese della difesa e di miglioramento dell’istruzione collettiva.
L’istruzione diventa il vero investimento di lungo termine, visto che il patrimonio più importante di cui disponiamo sono i nostri figli, peraltro sempre meno, e quindi forse meritevoli di una qualità e modernità dell’istruzione che possa fare da base alle crescenti necessità di innovazione della nostra società. L’istruzione quindi intesa non solo come istruzione dei giovani, ma come continuo, faticoso e necessario miglioramento delle capacità professionali di chi già lavora, con un processo di adeguamento continuo alle nuove sfide, in cui peraltro proprio l’Italia con le sue aziende di media dimensione ha dimostrato di sapere meglio reagire alle sfide degli ultimi anni.
Per lo sviluppo economico, l’agenda dell’Europa (e dei singoli Paesi, visto che realisticamente l’Europa intesa come istituzioni politiche sarà ancora relativamente meno importante senza una profonda revisione degli assetti istituzionali di cui non si vede nemmeno l’inizio) nei prossimi anni si intravedono alcune priorità:
- L’armonizzazione dei sistemi fiscali e l’uso della tassazione come strumento competitivo integrato. Alzare le tasse su persone e imprese in modo non coordinato serve solo a favorire chi non lo fa e a distorcere la concorrenza. L’esempio dell’Irlanda, e di altri piccoli sistemi Paese (Lussemburgo) che hanno beneficiato di questa concorrenza sleale, dimostra come si dovrebbe spingere per rafforzare l’omogeneità dei sistemi fiscali cercando di riscuotere tasse da chi prospera sul territorio europeo raccogliendo consumi molto cospicui senza versare una fair share del profitto generato (le magnificent seven per cominciare).
- La difesa e lo sviluppo delle filiere industriali su cui abbiamo vantaggio competitivo e non siamo attaccabili. Non si vede perché la licenza di un software Microsoft, che ormai è pressoché una tassa necessaria, non possa essere equiparabile alla visita di Venezia, Roma o Parigi. Siamo il luogo al mondo con la maggiore concentrazione di storia, patrimonio artistico, bellezza e arte del vivere. Ebbene cerchiamo di svilupparlo, renderlo attrattivo e farcelo pagare carissimo da chi ne vuole usufruire. In Italia l’offerta turistica è arretrata, molto migliorabile e andrebbe fortemente incentivata a tutti i livelli e su tutti i segmenti (dal lusso all’offerta di base) proprio per generare nel tempo tutte le risorse anche fiscali di cui abbiamo bisogno. E pazienza se questo significa edificare qualche centinaio di nuovi alberghi di lusso, che peraltro significa attrarre cinesi, indiani e americani che non hanno nessuno scrupolo nel lucrare il massimo dalle loro filiere ormai inattaccabili. Il turismo, ma anche la moda e il lusso in tutte le sue accezioni (tessile abbigliamento, casa, arte), la filiera agroalimentare sono i nostri patrimoni più grandi. Nessuno li può toccare perché vengono dai nostri tremila anni di storia (gli stessi che ci stanno rallentando nell’innovazione peraltro). Se non li sfruttiamo e li difendiamo a qualsiasi costo saremo pronti a soccombere senza nemmeno “averci provato”.
- L’utilizzo della tecnologia e l’istruzione diffusa come elemento di sburocratizzazione e di produttività dei servizi. Siamo molto indietro rispetto a chi in altri sistemi (Usa o Cina) si è mosso privo dei nostri lacci e lacciuoli. Ma in Europa abbiamo probabilmente la popolazione mediamente più educata ed evoluta nel vivere sociale. Forse potremmo beneficiare di una grande iniziativa, questo sì a livello europeo, di formazione di una classe amministrativa di livello unico al mondo. Una scuola di pubblica amministrazione a cui attingere, in ogni Paese e in modo “apolitico”, quei funzionari, insegnanti, medici che, pagati essenzialmente dall’amministrazione pubblica, possono dare una crescita di produttività straordinaria che nessuna azienda privata può dare. Abbiamo le risorse per farlo, serve capacità di attuazione e il riconoscere che è utile se non fondamentale nei prossimi dieci anni.
- Infine, una politica energetica davvero comune e integrata. Dopo svariate centinaia di miliardi di investimenti “verdi” (tra cui cento miliardi sciagurati e gettati alle ortiche dai provvedimenti del peggior Governo della storia Europea, cioè il secondo Governo Conte con l’incredibile, tragico e quasi ridicolo “bonus centodieci per cento”) non è accettabile che l’energia costi in Italia il doppio che in Spagna e il triplo che negli Stati Uniti. L’Economist in un recente studio faceva notare come in Europa le fonti rinnovabili siano già quasi al cinquanta per cento del fabbisogno, ma che la miopia degli interessi nazionali sia volta ancora costosamente a ridurre il vantaggio competitivo che deriverebbe da una completa integrazione energetica europea. Serve volontà politica e priorità, abbiamo speso molto ed è ora di averne i frutti meritati, depotenziando Russia e Medio Oriente che ci hanno su questo violentemente taglieggiato negli ultimi quarant’anni.
Difesa, istruzione, energia e settori strategici. Queste sono le vere priorità su cui discutere. Serve un assetto istituzionale degno delle sfide, non siamo condannati a essere una società decadente di massa. Possiamo e dobbiamo diventare il luogo migliore dove vivere sul pianeta, per democrazia, libertà, istruzione, cultura e bellezza. E la prossima volta, forse più che in questa tornata elettorale, troveremo e voteremo qualcuno che avrà portato avanti prioritariamente questi temi.
Articolo pubblicato su: https://www.linkiesta.it/

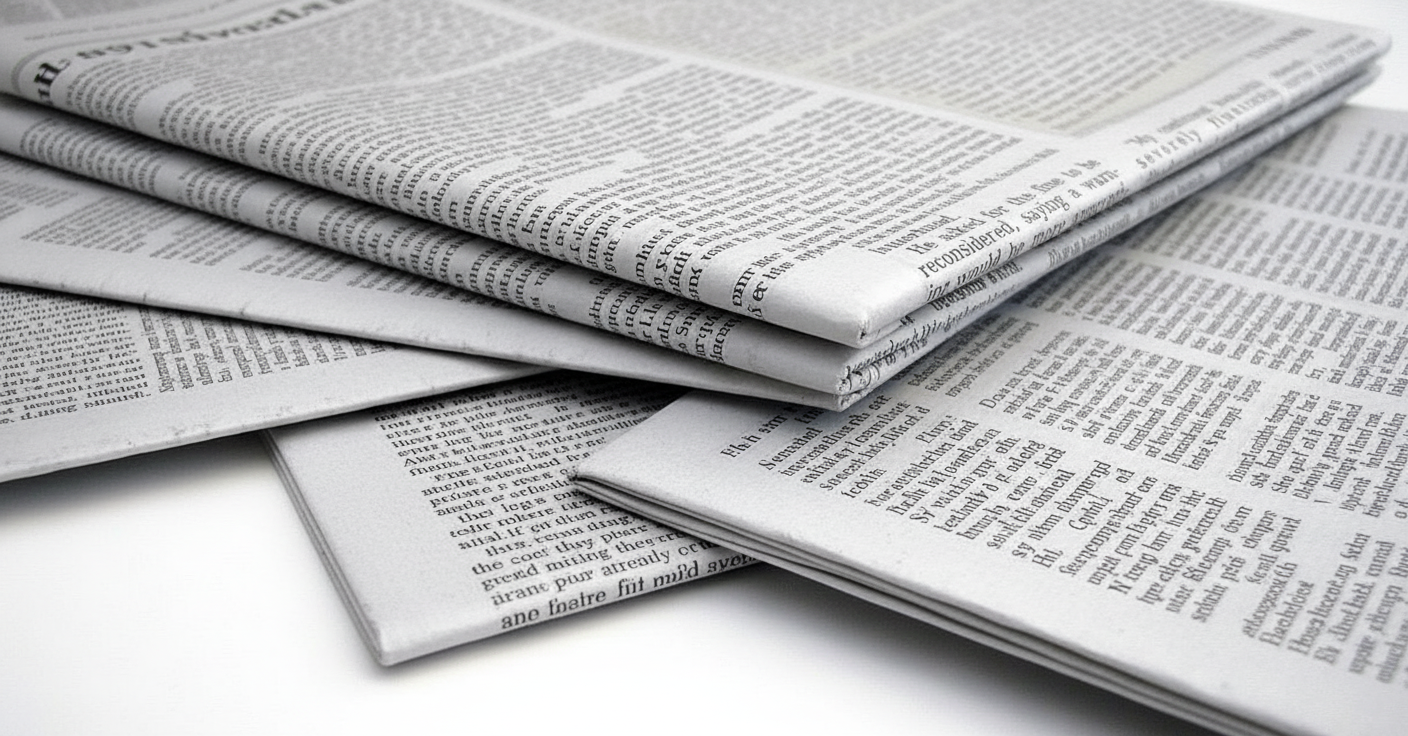
Giovanni Cagnoli
L’eccezionalismo americano che ha sempre caratterizzato il commercio globale viene cancellato da un presidente che fa l’esatto contrario di ciò che ha reso grande quella nazione. A trarne vantaggio sarà Pechino, mentre l’Europa dovrà adeguarsi e imparare a essere il nuovo baricentro dell’Occidente liberale. La decisione di Donald Trump di imporre pesanti tariffe su tutte le esportazioni verso gli Stati Uniti è economicamente folle, e porta il mondo verso un nuovo ordine globale unicamente per ambizioni politiche insensate. L’Europa e l’Italia dovranno reagire compostamente ma con determinazione, e adattarsi a un mondo in cui inevitabilmente – ma alla fine, forse, con beneficio per tutti noi – il centro economico e geopolitico globale diventerà la Cina.
Le tariffe imposte da Trump sono insensate e rasentano il suicidio economico. Ipotizzare che alzando i prezzi di tutte le importazioni si forzi il trasferimento degli investimenti industriali negli Stati Uniti è ridicolo anche solo da pensare, e non succederà per nessun motivo. Questo perché il costo dei fattori di lavoro negli Stati Uniti, in particolare la manodopera, resta elevatissimo, proprio perché l’economia americana, anche per effetto di un deficit di bilancio altissimo e di un indebitamento collettivo altrettanto alto, ha prosperato come nessuno al mondo negli ultimi vent’anni (e anche perché la manifattura rappresenta una quota minoritaria dell’occupazione in un’economia sviluppata, circa il quindici per cento).
Qualsiasi CEO o membro del consiglio d’amministrazione di una società multinazionale, almeno fino a quando Trump avrà autorità sulle due camere del Congresso (speriamo poco), sarà estremamente negativo sull’investire negli Stati Uniti a fronte di una politica economica volatile, dissennata e senza alcuna logica economica. Gli investimenti necessitano di stabilità e di condizioni sia legislative sia economiche di contorno prevedibili: nulla di tutto ciò esiste, almeno finché Trump ha qualche briciolo di potere. E oggi di fatto ha un potere quasi assoluto.
Quindi l’obiettivo dichiarato del presidente americano non verrà raggiunto, anche perché gli Stati Uniti entreranno in recessione a breve, con un incremento cospicuo dell’inflazione e un notevole deprezzamento del dollaro. La recessione è ovvia per l’impatto negativo dell’incertezza su aziende e consumatori, e anche per l’impatto delle tariffe di risposta (a partire da quelle che arriveranno dalla Cina). L’aumento dell’inflazione è altrettanto scontato. A parità di altri fattori, le aziende scaricheranno i dazi con un aumento anche pesante – e facilmente giustificato – dei prezzi. Alcuni beni non hanno sostituti prodotti negli Stati Uniti: dai cellulari Apple alle auto di lusso, fino alla moda. Altri ancora forse li potrebbero avere, ma installare la capacità produttiva per farli Made in USA richiede tempo, e il rischio che in un futuro non lontano le tariffe vengano meno, rendendoli antieconomici, fa sì che questi investimenti non verranno realizzati.
La caduta del dollaro è una conseguenza altrettanto scontata. Trump metterà una pressione indicibile sulla Federal Reserve, fino a minacciare la sostituzione del presidente Jerome Powell. Decisione che non è nei suoi poteri, ma che ugualmente diventerà oggetto di discussione nella narrazione totalmente distorta e falsa del presidente. La pressione sarà finalizzata al ribasso dei tassi di interesse su cui Powell dovrà almeno un po’ resistere, perché si troverà di fronte al peggiore scenario possibile per un banchiere centrale: recessione e inflazione insieme. Ma il solo parlarne o paventare la sostituzione di Powell con un fantoccio di Trump è negativa o fortemente negativa per il dollaro.
Tuttavia, il vero colpo letale al dollaro arriverà dai flussi di capitale. Gli Stati Uniti hanno goduto negli ultimi vent’anni di un’enorme concentrazione di flussi di capitale legati all’esplosione della bolla tecnologica: le magnifiche sette, cioè Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta e Tesla, capitalizzano oggi sedici trilioni di dollari con multipli assurdamente elevati legati al cosiddetto eccezionalismo americano, e cioè la concentrazione negli Stati Uniti di innovazione, libertà economica, free trade e management orientato alla creazione di valore. Tutto questo viene spazzato via in un colpo dall’eccezionalismo opposto di Trump: negazione del commercio mondiale, volatilità delle scelte, condizionamento delle decisioni allo status di amico o nemico personale del presidente, e in ultima analisi subordinazione della logica economica all’interesse politico di una singola persona.
In questo contesto è facile prevedere un massiccio flusso di vendita nell’ordine di due o tre trilioni di dollari da parte degli investitori non americani che non vogliono esporsi al capriccio del Caligola di Mar-a-Lago. Se due o tre trilioni di dollari – a cui si somma un trilione di dollari di deficit commerciale e quasi due trilioni di deficit pubblico non eludibili nel prossimo anno – vengono venduti nel mondo per reazione a Trump, l’offerta di dollari sul mercato sarà esplosiva, mentre la domanda probabilmente sarà minima. Difficile pensare che la Cina o il Giappone, già possessori di debito pubblico americano in dosi che si possono definire letali, e consapevoli che Trump tenterà di svalutare il dollaro più che può, acquistino dollari. Sulla probabilità di un massiccio flusso di investimenti negli Stati Uniti mi sono già espresso e quindi la logica economica e le rigide leggi della domanda e dell’offerta porteranno a una massiccia svalutazione del dollaro, per effetto di molte vendite e pochi acquisti, con ulteriori conseguenze negative sull’inflazione e con drammatiche conseguenze sulle economie dei Paesi in via di sviluppo.
Non sorprende che Larry Fink, CEO di BlackRock, che è il più grande asset manager del pianeta, ipotizzi la possibilità che il dollaro perda lo status di moneta rifugio a favore dell’oro (che veleggia ai massimi di sempre) o delle criptovalute o, più probabilmente, a una combinazione di euro, yen e yuan in una coalizione di volenterosi a difesa dell’ordine economico mondiale. Purtroppo per noi, una repentina caduta del dollaro (e me l’aspetto già nel 2025) ha conseguenze ulteriormente negative sull’economia mondiale, anche perché probabilmente fa parte dell’agenda di Trump e del suo principale consigliere economico (Stephen Miran), il quale in un Paese con decine di premi Nobel per l’Economia si distingue per la pochezza del pensiero.
Ci si può quindi aspettare:
- minore crescita economica mondiale (si stima 1,5 per cento in meno per un anno, che è un’enormità);
- maggiore inflazione statunitense;
- una significativa caduta del dollaro;
- una significativa caduta dei prezzi delle materie prime, petrolio e gas in primis, e la conseguente crisi di molti Paesi in via di sviluppo e di molte economie dell’area mediorientale (non la Russia, che avrà ben maggiori problemi del prezzo di petrolio e gas);
- un generalizzato e ulteriore calo dei tassi di interesse in tutto il mondo, più accentuato negli Stati Uniti, dove la leva monetaria è più potente, realistico che si possa inopinatamente ritornare a tassi inferiori all’uno per cento, che sembravano essere solo una breve anomalia in epoca Covid;
- una tendenza delle aziende a ridurre i rischi di catene di fornitura globali per evitare distorsioni da dazi;
- una marcata riduzione delle transazioni di fusioni e acquisizioni globali per effetto della sfiducia e dei rischi connessi a un commercio mondiale senza regole;
- un marcato aumento del premio per il rischio per le notevolissime discontinuità di tutto quanto sopra e quindi un prolungato periodo di ampia volatilità verso il basso dei listini azionari contrastato però dai tassi di interesse di nuovo prossimi allo zero;
- una forte tensione verso il basso dei rendimenti finanziari nominali, con conseguente messa in discussione dei flussi di capitale di risparmio a sostegno dei baby boomer ormai in pensione.
Quindi, in sintesi, mercati finanziari in subbuglio e soggetti a repentine crisi come nei giorni immediatamente successivi ai clowneschi annunci di Trump nel Rose Garden, maggiore disoccupazione, minore prosperità, tensioni sociali ovunque, forte riduzione del ciclo di investimenti nel mondo.
La domanda di fondo è: perché Trump fa tutto questo? Io credo che la motivazione sia eminentemente mercantile e sottilmente politica. Trump pensa di attivare la processione verso di lui di Stati sovrani, ma soprattutto di aziende americane per ottenere eccezioni a queste tariffe in cambio di favori o «deals», come li chiama lui, specifici. La nozione sottostante è che Trump non è al servizio del Paese, ma l’opposto: pensa di essere il dittatore unico e onnipotente (del resto lo hanno rivotato pur conoscendone le menzogne e le follie, e quindi si ritiene ormai intoccabile), e pensa di trattare con Stati, aziende o chiunque, forte del suo potere assoluto e incontrastato, distribuendo concessioni sui dazi in caso di obbedienza al suo volere.
«[Vladimir] Putin deve fare la pace se no metterò tariffe» è un’assurda menzogna, visto che la Russia non esporta praticamente nulla se non in Cina, viste le sanzioni, quindi le tariffe sono totalmente irrilevanti. «Se fanno concessioni fenomenali rivedo le tariffe» è il cosiddetto ramo di ulivo offerto a tutte le nazioni, e la Cina ha prontamente risposto con una contro tariffa del trentaquattro per cento, così come il Canada.
Ma la processione delle aziende americane inizierà a breve, e Trump chiederà contributi elettorali, promesse di perseguitare i suoi avversari politici, garanzie di parlare pubblicamente a suo favore e quant’altro possa definire perpetuamente il suo controllo sul Paese.
Il disegno è essenzialmente di diventare un autocrate simile a Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan o Xi Jinping, statisti che Trump ammira, tutti privi di contrappesi democratici. Molti professori universitari, giornalisti e opinionisti stanno lasciando gli Stati Uniti perché non vogliono vivere con uno pseudo-dittatore. Trump pensa che il mondo si divida in figure forti – lui prima di tutto – e imbelli fantocci della «passata democrazia» che lui non rispetta, non considera e sostanzialmente vuole calpestare.
L’Europa, con tutti i suoi difetti di costruzione, è il nemico pubblico numero uno perché, così come per Putin, è un esempio mondiale di libertà civili, alternanza democratica e rispetto della diversità. Quindi va distrutta prima che il fascino di un’Europa libera e prospera si insinui tra i fedeli adepti del Make America Great Again.
Per fortuna nostra e del mondo, tra soli diciotto mesi ci saranno le elezioni di midterm e, se le previsioni fatte sono realistiche, Trump e i Repubblicani saranno cancellati dal panorama di Camera e Senato, con gli Stati Uniti in recessione, il dollaro sottoterra, il deficit federale alle stelle e una crisi di potere contro la Federal Reserve. Io credo che sia possibile che il Partito Repubblicano si spacchi in due e la parte sana del partito si ribelli a tanto scempio. In un sistema bipolare, una tale evenienza rende molto bassa la possibilità per la parte deteriore dei Repubblicani Maga di essere eletti. In particolare, al Senato, Trump deve vincere ventitré seggi su trentacinque in palio e non sarà per nulla facile. Senza il controllo del Senato non passerà praticamente nulla delle intenzioni di Trump, inclusi i dazi, e soprattutto le elezioni presidenziali del 2028 saranno tossiche per i Repubblicani che abbandoneranno la nave di Trump in forze per evitare di essere travolti.
In questo quadro ci sono alcune implicazioni di second’ordine, forse meno evidenti oggi, ma di grandissimo impatto a medio termine. Il modello occidentale di sostanziale adesione alle scelte di costume, abitudini e comportamenti “americanizzati” è fortemente a rischio. Anche i più convinti sostenitori degli Stati Uniti nel tempo, e io sono uno di questi, avranno un sentimento negativo e le evidenti negatività degli anni passati (eccesso di mercantilismo, una discreta dose di superficialità, e qualche significativo errore di politica estera) non saranno più compensate dalla tradizionale posizione in difesa della democrazia, della libertà individuale e collettiva; né dall’idea di un ascensore sociale davvero diffuso o dall’amore per il fare. Il comune sentire che ci viene dalla Seconda guerra mondiale e dai soldati americani morti in Europa per salvarci dal nazismo è ormai lontano, mentre l’orrido ricordo recentissimo dell’umiliazione di Volodymyr Zelensky orchestrato alla Casa Bianca in diretta mondiale fa davvero disgusto.
È più che possibile che ciò che esce da questi Stati Uniti sia improvvisamente per nulla attrattivo, e più odiato, e che le negatività amplificate superino di molto gli aspetti positivi, a loro volta molto ridimensionati. Se così fosse, si andrebbe verso una polarizzazione dell’Occidente liberale, a cui si unisce di nuovo l’Inghilterra dopo la sciagurata Brexit, e di cui diventano parte integrante la Polonia, la ricchissima Scandinavia e i Paesi baltici. Ma anche i Paesi balcanici dell’est, una volta bloccati dalla cortina di ferro. Con il modello isolazionista, egoista e mercantile degli Stati Uniti, usi, costumi e comune sentire dell’Occidente sono un lontano ricordo. L’Occidente diventa l’Europa. Mentre, ad esempio, quel che stanno facendo gli Stati Uniti con la Groenlandia è molto vicino, per mentalità, a quello che fa la Russia di Vladimir Putin con l’Ucraina o che vuole fare la Cina di Xi Jinping con Taiwan.
La contrapposizione diventa “democrazie liberali contro autocrazie”. Se Trump riesce nel suo disegno autocratico (io ne dubito, ma potrebbe) il mondo come lo abbiamo conosciuto finora viene cancellato. Il primo ministro canadese Mark Carney lo ha detto con tono triste, ma fermo e pacato. L’ordine mondiale a cui siamo abituati è finito. È una tragedia, ma bisogna prenderne atto. L’Europa non ha scelta. Se prima l’ombrello americano consentiva liti da cortile perché garantiva sicurezza e democrazia, adesso il tempo delle liti è finito. Non si può più tollerare Viktor Orbán (perché non lo cacciamo dall’Europa?) né l’unanimità sempre e comunque, e si deve andare verso modelli di coalizioni di volenterosi. Il Green Deal non è economicamente sostenibile.
Il riarmo è una necessità assoluta e più importante. La difesa dell’autonomia dell’Ucraina è essenziale. Il riavvicinamento commerciale con l’Asia diventa un’altra necessità assoluta. Impostare un dialogo con la Cina che, per quanto molto interessata alla sua posizione di potere geopolitico in Africa e in generale nel Sud del mondo, non ha mai fatto scelte irragionevoli, diventa fondamentale. E se dobbiamo accettare qualche richiesta cinese, così sia. Xi Jinping ottiene un risultato incredibile e insperato molto prima del fatidico centenario della Lunga Marcia del 2049: la Cina diventa la prima potenza economica e commerciale al mondo con la collaborazione fattiva dell’Europa, un rapporto solido con la Russia e un antagonismo non superabile ma non bellico con gli Stati Uniti. In questo quadro, la difesa strenua dell’autonomia di Taiwan è meno importante se sul piatto ci sono rapporti commerciali preferenziali, fluidi e senza dazi o tariffe.
L’incremento dei salari reali in Cina rende questa possibilità molto reale, e se Xi non fosse manicheo su Taiwan una soluzione forse si potrebbe configurare scongiurando un focolare di possibile guerra. Cosa pensino gli Stati Uniti sul tema diventerebbe pressoché irrilevante, e sarebbe una storica vittoria su un tema fondamentale per la Cina. E un messaggio al resto del mondo. I rapporti con l’India – e in minore misura con Indonesia, Vietnam e Cambogia, gli unici grandi Paesi a non fronteggiare ancora una crisi di calo demografico, vanno salvaguardati e coltivati. La potenza dell’India nella manodopera di servizio è nota, e il mercato asiatico potrebbe garantire enormi possibilità di sviluppo per tecnologie e beni di investimento manufatturieri di origine europea. Lo sviluppo di accordi di free trade con l’India e il Sud Est asiatico è quindi una priorità importante per l’Europa, che non avrà demograficamente disponibilità di manodopera per produzioni a basso valore aggiunto e quindi non ha nulla o quasi da perdere a comprare beni di consumo di basso prezzo dall’Asia, quando la Cina diventerà troppo costosa per fornirli. Per la politica italiana, così come nel 1948, la politica estera diventa fondamentale e assoluta. Stare con Trump non si può e non si deve.
Stare con i pacifisti tanto meno. E non si può nemmeno stare con la cultura woke, che è una causa importante di frustrazione che ha generato il mostro Trump. Non a caso Giuseppe Conte, Matteo Salvini e in minore misura Elly Schlein sono espressione di chi sta dall’altra parte. Giorgia Meloni per ora sta in una posizione di equilibrio a tratti equivoca (a favore del riarmo e della difesa dell’Ucraina, ma non contro Trump) ma dovrà scegliere in modo chiaro e netto. Se saprà farlo avrà probabilmente, anche per mancanza di avversari credibili, un lungo futuro alla guida del Paese.Il Partito democratico dovrà scegliere nettamente tra l’armocromia pacifista e le posizioni di Paolo Gentiloni, Giorgio Gori e Irene Tinagli. Da tempo sostengo che fossero incompatibili.
Adesso diventa lampante, e anche qui l’equivoco non può durare nonostante tentativi abbastanza patetici di sostenere che si tratti di piccolezze. Il Paese arriva abbastanza stremato dopo lo spreco di tempo e di denaro assurdo del governo Conte (centodieci miliardi di debito per il 110%, il più grande furto a danni del contribuente della storia repubblicana) e dopo vent’anni di governo di sinistra con intervalli berlusconiani dove nulla si è fatto per superare lo storico vizio del tassa e spendi.
Il livello dei redditi è bassissimo rispetto alla media europea e il debito pubblico morde. Ma in uno scenario in cui la Germania esce dalle paranoie anti-debito, la Francia esce dal lassismo migratorio che ha dato il via al Rassemblement National, e forse anche l’Italia esce dall’equivoco dell’ostilità alle imprese, abbiamo una speranza di potercela fare. In fondo, i Cinquestelle si sono dimostrati quello che sono, cioè essenzialmente incompetenti; la Lega ha avuto la sua stagione, ma è fossilizzata sulla difesa di un uomo solo ossessionato dal potere personale e altrettanto incompetente; il Partito democratico ha seri problemi di alleanza con Conte e il suo opportunismo egoriferito.
Nessuno coagula più che una minoranza non rilevante. In comune hanno solo la voglia di essere al governo e null’altro. Giorgia Meloni può riuscire, se si convince, a coinvolgere nel suo governare persone competenti e di peso (ci sono, e sarebbero disponibili, probabilmente) superando diffidenze ataviche, se trova il modo di sfruttare al meglio il jolly rappresentato dal carisma e dalle idee di Mario Draghi, e se esce da una cultura un po’ provinciale di accerchiamento e di sottogoverno. Non è facile, ma si può fare trovando lungo la strada alleati di peso sia elettorale sia ideologico. La vecchia legge che non si governa in Italia senza l’appoggio degli Stati Uniti non vale più.
Nel vuoto di potere diventa di fondamentale importanza dipingere un quadro di sviluppo economico e sociale armonico che il nord delle imprese ha già in parte sposato abbandonando i rigurgiti di Salvini, ed evitando di ammiccare a nostalgie che in questo contesto sono proprio insensate e fuori tempo. Servono idee semplici, capacità di porle agli elettori, carisma, buon senso e anche evitare le ubriacature di potere personale di cui gli italiani sono ormai consci. Purtroppo, lo scenario esterno non sarà per nulla favorevole, ma nei passaggi chiave il Paese ha sempre dimostrato capacità di reazione e di resilienza.
E magari, con la guida di una presidenza della Repubblica di Mario Draghi, potrebbe anche trovare una stagione di riforme lungamente attese e mai davvero realizzate di cui c’è urgente bisogno, e su cui qualche timido germoglio sembra nascere.
Articolo pubblicato su: https://www.linkiesta.it/


